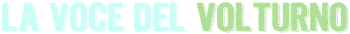UNA NOTTE INSONNE…DELLO SCRITTORE CASTELLANO VITTORIO RUSSO
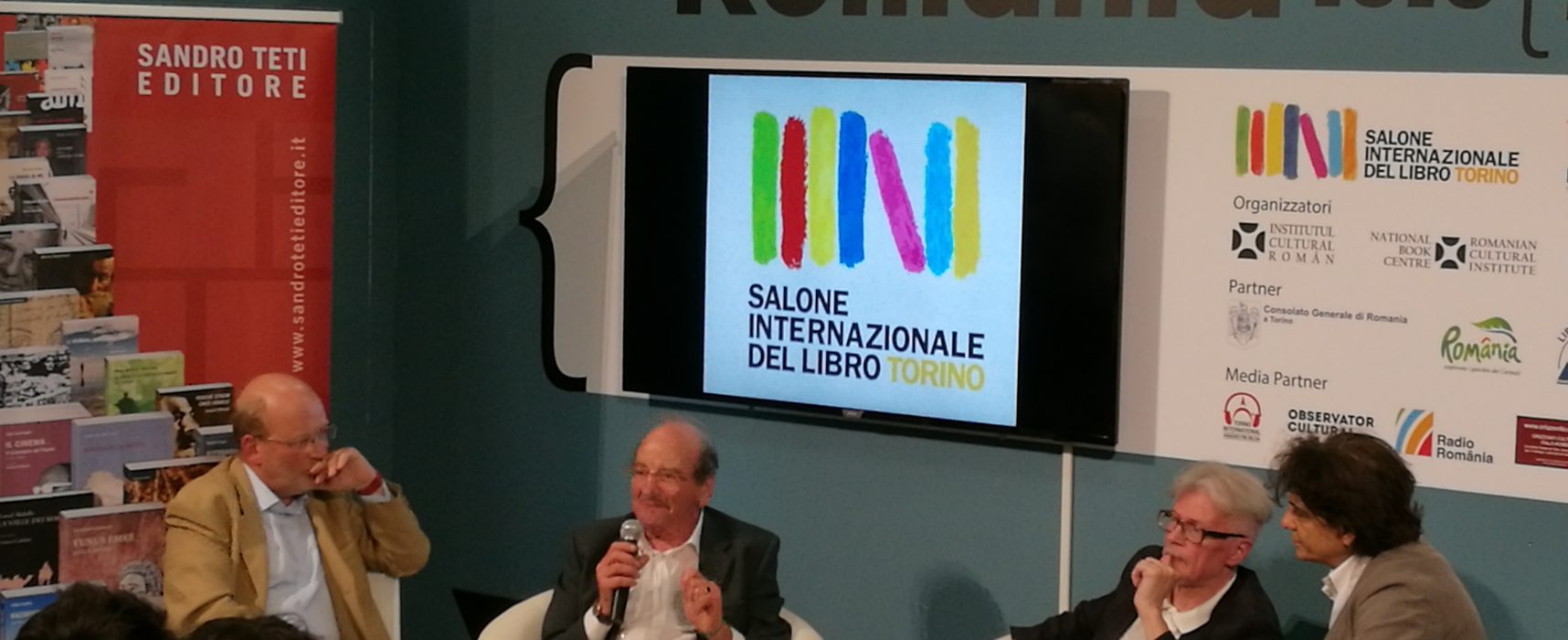
…è seguita una notte insonne che ho percorso quasi per intero, senza soste. Soprattutto per le ansie create dalla fantasia nel teatro del buio. La notte è sempre magnifica quando diventa pretesto per riconciliarsi con sé stessi. Non questa però. Non smanio che di vedere la luce del crepuscolo mattutino. Ma, come ha scritto qualcuno, per arrivare all’alba bisogna percorrere tutta la strada nera della notte. E di questa notte qui, a Floreana nelle Galápagos, so già che, come tutte quelle non dormite, durerà interminabilmente. Forse non ne conserverò ricordi perché non avendola vissuta non sarà neanche mai esistita. I giorni hanno un nome per essere distinti e ricordati, le notti no, al più si dice: ricordo quella notte che… Eppure, sento che questa notte ha una sua singolare identificabilità .
Cerco a tentoni il Don Chisciotte nella tasca del mio sacco. Leggere qualche pagina mi rilasserà . Tiro fuori il libro, ne sento la carta slabbrata sotto i polpastrelli. Ne immagino la figura sulla copertina del protagonista a cavallo con in testa l’elmo di Mambrino, alias una bacinella da barbiere. Chiudo gli occhi. Come si fa a leggere quando la tensione ti stira come collo di camicia sotto un ferro rovente? Indugio ancora con riflessioni sul fascino misterioso della notte, su quella sua capacità di sollecitare interrogativi al buio, tutti senza risposte. Quando essa è vissuta da svegli, con intenzione, è tutta un’esuberanza di vita, è intensità , è un caffè forte, è un saluto silenzioso alle cose, alle luci, alle finestre con il chiarore che sta per spegnersi. Se sei fuori perché non riesci a dormire temi le persone che incontri: le persone al buio sono sempre sospette. Poi ragioni, di notte esse sono le meno ipocrite perché di notte escono quelli che non hanno bisogno di un’identità , quelli che magari neanche ne hanno una. Di notte escono quelli che di giorno non esistono perché nessuno li chiama per nome, perché sono i respinti. Solo la notte li accoglie. Come questa notte a Floreana che rifiuta la mia identità . Eppure, non ho scelto io di non dormirla, anzi ho perfino cercato di agevolare il sonno fasciandomi la testa con un lenzuolo. È lei che mi respinge e mi spalanca solo l’oscurità delle cose sconosciute, mi schiaccia nella tempesta dei pensieri. L’incubo arriva quando sento strumenti che suonano all’impazzata, dentro, senza farsi armonia. Si fa denso il tempo e riesco a percepire la scansione dei secondi, come gocce di piombo fuso, perfino di un orologio muto come il mio, fermo ormai da giorni.
Scorgo attraverso il filo schiuso della finestra una striscia di cielo profondo e amico. Mi conforta per un attimo, gravido com’è di tante stelle che gli danno consistenza. Le vedo che schizzano come faville e pare vogliano incendiare la volta celeste. Sento un soffio impercettibile, sembra quasi pioggia. Allungo un piede e con un alluce schiudo un po’ di più l’imposta, senza far rumore. Vedo altre stelle, lontane, mucchi sfrangiati di punti luminosi. È uno sciame di lucciole confuso nel nero di una siepe alla stessa distanza delle stelle. Non so dove focalizzare lo sguardo. Lucciole e stelle: osservo meglio al buio, sono proprio alla stessa distanza. Una pioggia impercettibile pare sollevarsi verso il cielo come se piovesse al contrario, tanto è pulito e incontaminato il firmamento. Entro nel sonno ma dura poco. Inciampo subito nell’agitazione dell’incubo che al sonno mi strappa. Un sonno popolato da ombre leggere, da mostri verdi con diabolici piedi caprini, da creature deformi e sconosciute impietrate nelle selve fossili delle Galápagos. Hanno facce di statue olmeche, perfettamente rotonde.
Poi, in una sequenza interminabile, si sono sovrapposti l’impaccio del caldo umido, lo smarrimento nella foresta, l’incertezza di trovare l’orientamento, gli occhi degli aculei nella corteccia degli jasminocerei puntati addosso, l’intralcio dello zaino, la pioggia brodosa, le iguane tra i piedi, le strida in alto dei gabbiani e, non ultimo, uno stormo di pellicani beffardi a scaricare dall’alto piogge di escrementi per affrescarmi scarpe, pantaloni, felpa e cranio. Mi tergo inutilmente l’inesauribile colatura che come pittura avorio gocciola da un pennello invisibile e mi scorre dalla fronte nei solchi lacrimali… Tutto si è tradotto in una stretta bruciante all’epigastrio nell’impossibilità di sentir scoppiare in gola un grido liberatore.
Purtroppo, nel sonno si è sempre senza pelle, negli incubi anche di più, soprattutto per me impreparato a vivere un sonno di incubi. Mi piace immaginare questa stanza attraversata dal buio e a tenuta ermetica per impedire l’accesso a presenze indesiderate. Ma gli incubi passano attraverso i muri, di soppiatto, non puoi evitarli, non puoi negar loro il consenso a entrare, devono imperversare liberamente e svanire da soli. Mi sento assolutamente privo di difese, tutto è propizio alle fantasticherie perciò sono pure esposto all’angoscia. Sì, l’angoscia, quella nella sua accezione più autentica cioè mancanza di respiro tipica degli incubi, come il panico che nasce dall’oppressione, che poi è gemella dell’angoscia… Mi sveglio e mi risveglio di continuo, ma non so se mi sono mai addormentato. L’incubo, insomma, si fa ancora più incubo e io ne sono soffocato. Diventa dolore: la forma più autentica del dolore fisico. Mi tende le ossa, quasi avessi un peso legato a entrambe le caviglie e fossi sospeso per le braccia a un uncino inquisitoriale nel firmamento.
Infine, mi sveglio davvero e di colpo. Sono sveglio, eppure mi scopro capace di perpetuare lucidamente l’idea fissa di non aver chiuso occhio. La luce che filtra finalmente annulla le incertezze. Bisbiglio due sillabe, tanto per accertarmi di essere uscito dall’incubo e di avere ancora voce. Prima di provare a svellere le follie dal cervello rimuovo le schegge vulcaniche che ho raccolto in giro per l’isola e che sono finite (chissà come poi) tra le lenzuola in cui sono attorcigliato. Le punte scabrose sono sicuramente gli occhi pungenti degli jasminocerei dell’angoscia di prima.
Le angosce non hanno mai una sola causa. La prima è quella indecifrabile che ho descritto. La seconda è determinata dal russare luciferino di Duccio dall’altro lato della stanza comune che, pur immensa, non riesce ad attutire l’inestinguibile gorgogliare etneo del mio compagno. Provo a descriverlo in visione minimalista e per difetto: sbuffi, ansare di cornamuse, strombazzare di bombardini del giudizio, arrancare affannoso e stridio di denti di naufrago affamato, respiro schiumoso da condannato, sbavìo fitto e un rullare inarrestabile, profondo, vibrante come se fosse emesso da cento gole di bronzo, un tambureggiamento vigoroso di grancasse simile a quelle rajasthane dal diametro di due metri. E poi, quasi a preannunciare la chiusura dell’ultimo movimento di questo perfido concerto, un ronzio sottile di alveari. Due, tre, dieci alveari in crescita come un’onda seppellitrice, simile al crescendo delle trombe del giudizio nel Requiem di Verdi. E finalmente una deflagrazione di tuono biblico pari all’esplosione di un vulcano. Segue una cascata sonora di magma con zampilli di fuoco liquido e un filo di bava, voglio dire di lava, che fluisce dal cratere della bocca del mio compagno.
Duccio, che pure non è di poco sonno, si è svegliato di soprassalto, lui per primo, atterrito dal suo tuonare… Che vuoi dormire in queste condizioni? Altro che Ulisse fra Scilla e Cariddi. Lui almeno aveva solo uno stretto da superare, io la dimensione di un sonno inquieto vissuto da sveglio da cui si esce soltanto quando spunta tutto il sole.
E finalmente il sole spunta!