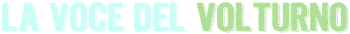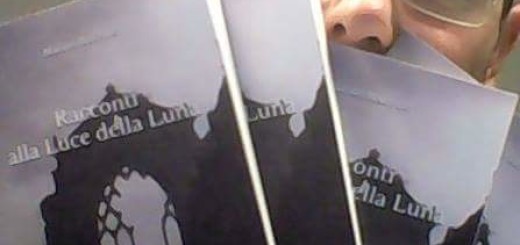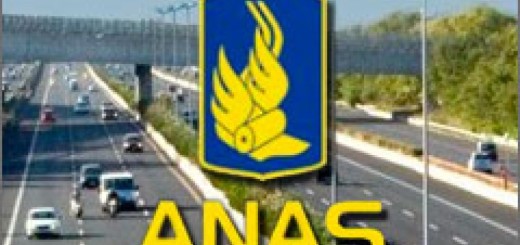SIAMO ALLA FINE DEL RACCONTO “SULLE ALI DEL MITO” DELLO SCRITTORE CASTELLANO VITTORIO RUSSO
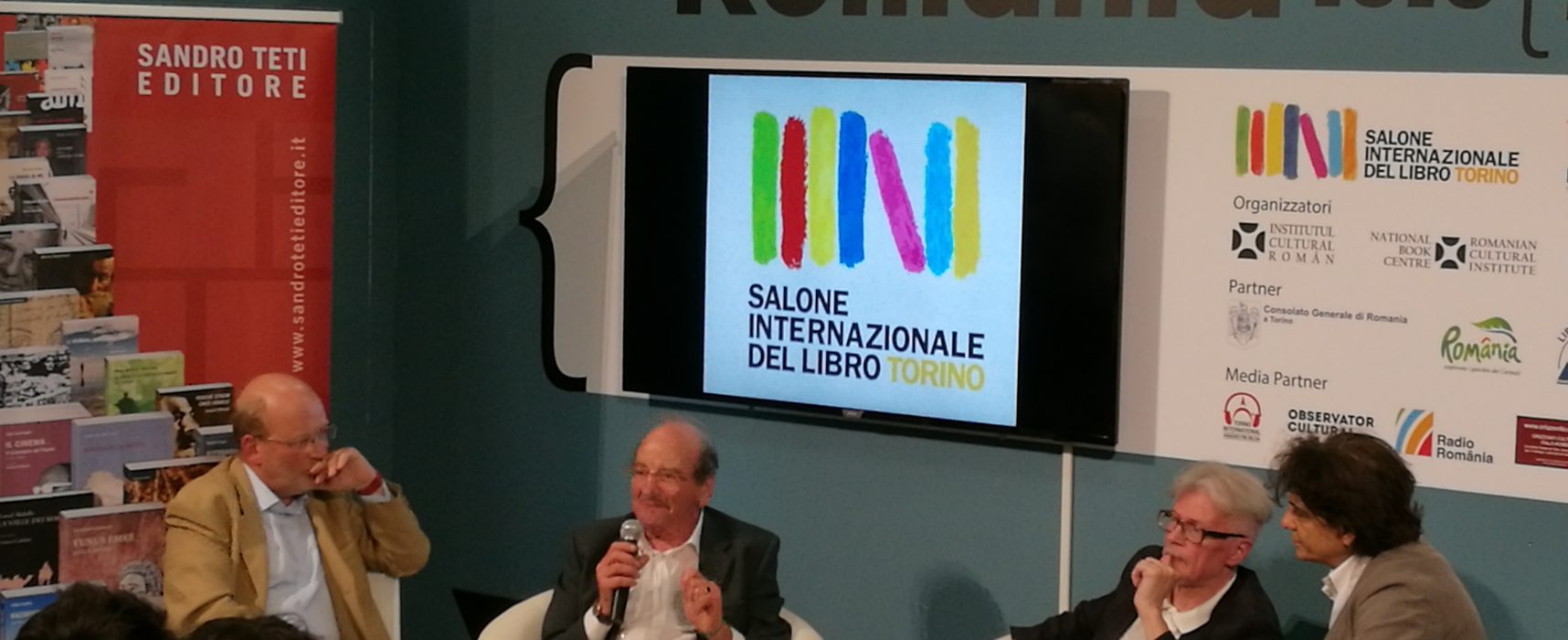
4^ ED ULTIMA PUNTATAÂ
Mi sono fermato infine a comperare un paio di quelle ciambelle giganti chiamate koulouri. Sono coperte di semini di sesamo e hanno un sapore indefinibile eppure familiare, come di pane siciliano insaporito con menta, finocchietto e aglio. È forse lo stesso sapore di quelle antiche, di quelle ciambelle, esse pure coperte di semi, a forma di mezzaluna che venivano offerte ad Artemide, la dea dei boschi solinghi…
A Piazza Omonia ho preso la metropolitana per l’albergo dopo aver percorso l’elegante Panepistimiou sulla quale si trova lo splendido edificio del Museo di Numismatica, che fu anche la dimora di Schliemann. Più oltre si leva la costruzione neo-classica dell’Accademia poco distante da due bianche colonne ioniche sui cui capitelli si ergono le statue di Apollo e di Atena. Più avanti c’è l’Università con gli affreschi vivi di colori superbi sotto il portico sorretto da colonne quadrate e, infine, la Biblioteca Nazionale.
Ormai assuefatto dopo giorni, riconosco a memoria la voce elettronica che annuncia la prossima stazione: Epòmeno: Evangelismos, e poi Mégaro Mousikìs e Ambelokipi. Ad Ambelokipi scendo. Risuonano in sottofondo le note del Titano di Malher. All’aperto, invece, mi aggrediscono i timbri sottili dei buzuki e degli uti, gli strumenti a corda che accompagnano col loro suono triste la musica rembetika, equivalente greco del blues.
Il viaggio di circa settanta chilometri fino a Capo Sùnion è durato un attimo. Si attraversa la magnifica cornice del golfo di Sarònico con la veduta di spiagge dalla sabbia sottile come polvere e di costiere scoscese, incredibilmente deserte. Il mare è di un indaco profondo, intenso come il blu di Prussia di una tela di Alma Tadema. Incantevole! A tratti, dall’alto delle colline che fiancheggiano le sponde fino alla punta meridionale dell’Attica, la superficie liquida diventa improvvisamente cangiante, quasi fosse attraversata di colpo da scariche elettriche e da guizzi frenetici di una vita sconosciuta. Da indaco diventa viola e poi celeste e verde. Una metamorfosi delle acque che giustifica tutti i miti di trasfigurazione di cui ha scritto in versi eterni Ovidio, a giustificare le metamorfosi delle Oceanine, figlie di Teti.
Il tempio di Poseidone sorge sull’estremità ultima di Capo Sùnion. Nessun posto più di questo poteva esprimere meglio la bellezza vigorosa del paesaggio marino e meglio corrispondere al profilo brusco e tenero del dio del mare. L’opera fu realizzata nel quattrocentoquarantaquattro a.C., verosimilmente dagli stessi architetti che diedero vita al miracolo costruttivo dell’Acropoli: Ictino, Callìcrate e Fidia. Ancora oggi, benché ridotto a sedici colonne doriche e pochi rocchi soltanto, le rovine sono imponenti e austere. Immaginabili sono le emozioni e la sensazione di sicurezza che doveva suscitare nei naviganti la vista della sua mole e l’approssimarsi delle sponde amiche. Non meno suggestivo è il paesaggio visto dall’alto dei sessantacinque metri dello sperone di roccia sul livello del mare su cui sorge il tempio. Verso nord, si notano le vestigie lontane e appena distinguibili del tempio di Atena Sùnia.
L’orizzonte è terso e l’atmosfera purissima, tanto da poter scorgere senza difficoltà il profilo dell’isola di Égina, nel golfo di Sarònico a ponente e, più oltre, quello bruno della costa del Peloponneso. A sud, invece, ho scorto le isole di Kèa e di Sèrifo, ma le ho identificate solo dopo su una mappa.
Nell’ora del tramonto in cui l’aria si addolcisce di suoni misteriosi e di nenie che evocano canti polverosi e antichi pianti di vedove spose, di guerrieri e naviganti, ho accarezzato quelle rovine con occhi di nostalgia, quasi vi fossi ritornato dopo una lunga assenza. Mi sono allontanato camminando quasi in punta di piedi su rocce consumate dal passo dei secoli, eppure ancora intatte. Quantunque tante volte scorto dal mare in un passato di navigante, m’incanta solo ora la gravità di Sùnion. Sotto di me respira roco Poseidone, assopito nella carezza spumosa di tremila Oceanine, mentre l’ultimo sole si disfa sulla linea rugosa del Peloponneso in un sacrificio di luce sanguigna.
Sulla via del ritorno mi sono fermato al Pireo per una passeggiata lungo il porto piccolo, noto come Microlìmeno. Una passeggiata tra odori frizzanti di pesce, di ruggine, di salsedine e di sabbia bagnata. Non era ancora buio quando sono rientrato ad Atene usando il velocissimo tram dalle linee eleganti e moderne di un noto stilista italiano.
Era presto pure per rientrare in albergo e mi sono ricordato una volta ancora del poeta-ciabattino Melissinos. Da Syntagma, a piedi, mi sono avviato verso Monastiraki e sono ritornato a Odos Agia Tekla. Il negozio era aperto ora. Era immerso in un odore intenso di cuoio profumato e sommerso da caterve di oggetti disparati: scarpe, sandali, ninnoli, strisce di cuoio, fibbie, parrucche, fermagli, sculture di marmo, mentre strideva nel retro un trapano a mordere il metallo.
Il poeta, l’ho riconosciuto subito, è un signore senza età , ieratico come un profeta, gli occhi dolcissimi sotto una chioma bianca e fluente che si confonde con una barba da filosofo peripatetico. Ci salutiamo come fossimo vecchi amici. Parliamo di mitologia, anima della sua poesia, io affascinato dal suo inglese essenziale, frammisto a solari termini italiani. E parliamo di tirsi e di giochi istmici e di processioni elusine, del cavallo di Troia e dello scudo di Achille e, infine, anche di pepli e di hhhiton e di hemation di cui ero all’affannosa ricerca per appagare un sogno…
Melissinos non mi è parso affatto stupito della mia curiosità ; pare infatti sia abbastanza frequente questa richiesta da parte molti turisti sognatori del passato, così li ha definiti, fissandomi. E qui ha voluto presentarmi qualcuno. Ha chiamato con voce autorevole un paio di volte: Pantelis, Pantelis. Lo stridio del trapano si è spento di colpo e Pantelis, asciugandosi le mani su un grembiule di cuoio bucherellato da spruzzi di fuoco di fiamme ossidriche, è venuto a presentarsi.
Ho conosciuto così il secondo artista di casa. Pantelis è un affermato autore di teatro, commediografo, musicista, filosofo, poeta, disegnatore di costumi e, naturalmente, ciabattino come il padre. Ecco, dunque, perché tutti m’hanno suggerito di venire qui se ero interessato ai costumi della Grecia antica. Pantelis disegna costumi per le sue commedie, e con una punta di orgoglio ha voluto mostrarmene i bozzetti. Naturalmente non sono oggetti in vendita. Sono rimasto affascinato mentre il poeta-padre seguiva orgoglioso questo splendido figlio parlare con disinvolta leggerezza di storia greca e di miti e della trama della sua ultima opera, Bacchus (così, proprio in latino!) che ha avuto uno straordinario successo di pubblico e di critica. Nella trama che mi è stata spiegata ho letto la vena antica della saggezza ellenica, ho scorto il profilo del filosofo di quarant’anni che è Pantelis: un poeta che vuole creare la bellezza intorno a sé e invita gli altri a imitarlo. Sostiene quest’uomo che l’Ermes di Prassìtele, i Propilèi di Mnesippe, il Partenone e tutti i capolavori greci del passato furono concepiti per creare bellezza e armonia. La bellezza quale pre-requisito della libertà . L’universo cerca la libertà e non sa che si raggiunge solo attraverso la bellezza e l’armonia. Noi non possiamo mutare il ciclo naturale del determinismo, ma possiamo tener viva la fiamma della civiltà con il sorriso, la grazia e l’armonia, appunto. Questa, in sintesi, l’essenza del pensiero di Pantelis.
Ero così intrigato dalla conversazione che non mi sono accorto dell’ora. Erano passate le otto e il negozio chiude normalmente alle sette. Ma io avevo ancora tante cose da capire e mutuare dalla placidità dei due Melissinos. Li ho invitati a cena. Niente da fare, naturalmente, non si usa qui, come non si usa da noi essere invitati da chi viene a casa tua, anzi è quasi offensivo farlo. Qui come da noi, nella Magna Grecia, il forestiero è tuo commensale per definizione, anche se non hai da offrirgli che un una fetta di pane e tre olive. A me pareva tuttavia poco opportuno accettare l’invito. Tuttavia l’insistenza è stata così spontanea e calorosa che ho annuito, adulato e felice.
Troppo tardi per comperare dei fiori per le donne di casa. A casa Melissinos però non c’erano donne. La casa-museo del poeta-ciabattino-padre, poco distante da Monastiraki, era opaca di odori longevi. Odore di carta bagnata, di pelli odorose e di miele, che frequente com’è o come io l’ho sentito in questi giorni, mi sembra sempre più l’odore naturale della Grecia. E poi: libri, calchi di statue antiche in grandezza naturale, frammenti di colonne, vecchie stampe e diplomi alle pareti, cimeli e oggetti naïf dappertutto. Mi muovevo con estrema attenzione timoroso di far danni, come mi capita spesso. La stanza grande come un antico mégaron, in mezzo alla quale troneggiava un pesante tavolo, era tutta rivestita di pannelli di legno scuro, lucenti di cera e separati da lèsene di marmo verde.
C’era anche qualche altro ospite a cena e ho capito che non ne mancano mai in questa casa. La tavola, infatti, era stata imbandita per sei persone. È continuata gradevole la mia conversazione con Pantelis, mentre il padre dava disposizioni in un greco incalzante al cameriere cingalese. Pantelis si esprimeva con cadenze lente e un accento americano calcato, anche un po’ troppo. Ha studiato negli Stati Uniti dove si è laureato in Arte al Parsons di New York. Tutto il suo pensiero sembra essere racchiuso nel suo Bacchus del quale è autore di testo, musica, coreografia così come dei costumi. Solo la produzione non gli appartiene. La commedia è basata su antiche versioni del mito di Dioniso-Bacco del quale l’autore ha cercato di decifrare l’aspetto e il senso più autentico. Bacco, infatti, per Pantelis è il senso stesso della vita, il simbolo fondamentale della natura e della bellezza quale sua espressione primaria. Nell’opera l’autore pone in rilievo con sottile ironia l’ansia che opprime l’uomo moderno, la sua smania di correre, l’assurda fretta che è una similmente assurda perdita di tempo mirata a un accumulo di beni materiali, effimeri e banali. Bacco è invece il senso dell’eternità che la vita racchiude, l’abbandono al ritmo dell’esistenza, l’amicizia, l’amore, il sorriso e un bicchiere di vino che basta per suscitarli. La gente chiude gli occhi per non vedere la semplicità di tutto ciò…
Verso le dieci sono giunti alcuni altri ospiti e una figlia di Stavros, Tea col figlio quindicenne, Thiseos, delizia del nonno. Tea: senz’età lei pure, aveva un volto acuto dal profilo fiero e due trecce nere che le fluivano sul collo e sul petto, come a una bruna Andromaca. Gli occhi erano scuri, luminosi, come coperti da un velo di luce. Parlava un italiano pieno di vocali chiare, mediterranee… luna pronunciato quasi come lana, e vuoto come guato… Ha ascoltato curiosa le mie curiosità . Insegna danza classica e aiuta il fratello nella parte coreografica degli spettacoli. Le ho accennato del mio libro di miti in bozze: La Decima Musa, ragione segreta forse di questo mio viaggio in Grecia. Il titolo l’ha stupita e l’ha stupita che io, uomo di questo tempo, conoscessi a memoria, fuori dal tempo, il nome delle altre nove muse, citate per amore e non per saccenteria…
Di tutta la cena ricordo solo gli infiniti antipasti mezedes a base di keftedes e di barbunya, le odorose triglie fritte alla griglia e ordinate in un immenso vassoio guarnito di foglie d’uva. Il bicchiere di vino cui ha accennato Pantelis era solo un’esemplificazione, una pars pro toto, perché io credo di averne bevuto qualcuno in più, soprattutto di quello resinato all’essenza di pino.
Per tutta la serata ci ha accompagnato la Rapsodia in blu di Gershwin e anche su questo Pantelis, rapsodo egli stesso con una voce fiorita e suadente come un’onda, ha avuto qualcosa da dire.
Ho lasciato la casa dei Melissinos intorno alla mezzanotte con la promessa di un incontro qui, ad Atene, di nuovo. Ho fatto appena in tempo a salire sull’ultimo metro per l’albergo.
***
Un viaggio in Grecia è sempre un ritorno a casa, nella casa in cui nascemmo idealmente tutti noi, figli della cultura che ci distingue e distingue il nostro modo di sentire e di essere. E alla Grecia ho avvertito pure il bisogno di esprimere la mia gratitudine con un viaggio che vorrei chiamare gioioso pellegrinaggio… alla Grecia che ha sentito di dovere all’umanità il dono della civiltà e non è morta con questo debito.
Si può non crederlo, ma questo è il paese dei moti del cuore, il paese dove, parafrasando Marquez, con le lacrime si annaffiano i fiori. Ma è anche il paese delle coincidenze inspiegabili. Si può essere scettici fin dove si vuole, ma se a Delfi un fiore ti piove sul capo mentre per gioco ti cimenti a consultare il tuo oracolo beh, allora devi convenire che forse gli dèi non sono morti e non sono nemmeno in letargo. Ci scrutano sornioni da lontano e di tanto in tanto tornano tra noi a provocarci con la loro malia e la loro malizia, senza pretendere altro che la nostra simpatia.