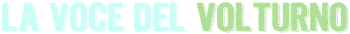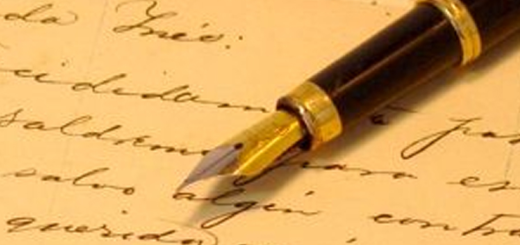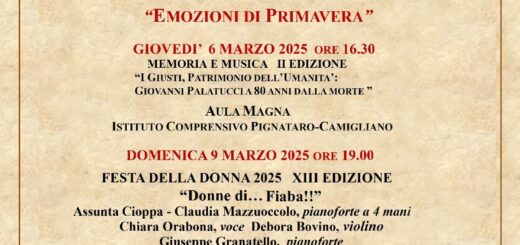S.Maria La Fossa- Protezione Civile
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
  (P.I. Giuseppe PASQUALINO)
![]()
ECOSISTEMA RISCHIO 2011 Monitoraggio sulle attivitÃ
delle amministrazioni comunali
per la mitigazione del rischio idrogeologico
Indagine realizzata nell’ambito di “OPERAZIONE FIUMI 2011”
campagna nazionale di monitoraggio, prevenzione e informazione per la mitigazione del rischio idrogeologico realizzata nell’ambito del progetto
Ecosistema rischio di Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile
Ottobre 2011
1
1. Introduzione
Ecosistema Rischio
Attraverso la nostra indagine sono state monitorate le attività delle amministrazioni comunali campane classificate nel 2003 dal Ministero dell’Ambiente e dall’Unione delle Province Italiane a
Le amministrazioni comunali possono intervenire per contrastare il rischio idrogeologico essenzialmente in due diversi settori:
• nelle attività ordinarie legate alle gestione del territorio, quali la
• nella redazione dei
L’indagine ha dunque voluto verificare l’effettiva realizzazione di tali interventi monitorando sia il livello attuale di rischio sia le attività svolte dai comuni per mitigarlo. Nella scheda inviata per l’anno 2011 alle amministrazioni comunali, abbiamo ritenuto opportuno valutare la presenza in zone esposte a pericolo di esondazione dei corsi d’acqua o a rischio frana oltre che di abitazioni e insediamenti industriali anche di strutture sensibili (come scuole o ospedali) o di strutture ricettive turistiche (alberghi, campeggi, ecc. ) o di strutture commerciali. Inoltre, abbiamo chiesto ai comuni di indicare una stima del numero di cittadini che vivono o lavorano ogni giorno in zone esposte a pericolo.
Nella seconda parte del questionario abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sugli interventi per un corretto uso del suolo, che sappia limitare l’urbanizzazione eccessiva delle zone particolarmente esposte a rischio idrogeologico. Abbiamo valutato, infatti, l’eventuale avvio di pratiche per la delocalizzazione di strutture presenti nelle zone soggette a maggiore pericolo e il recepimento nel piano urbanistico delle perimetrazioni contenute nel PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) al fine di stabilire i vincoli all’edificazione delle zone a rischio. Abbiamo chiesto, inoltre, se sia stata realizzata dal comune o da qualunque altro ente preposto una manutenzione ordinaria delle sponde o delle opere di difesa idraulica; se siano state realizzate opere di messa in sicurezza e di quale tipologia; se siano stati programmati, nell’ambito della programmazione nazionale o regionale sulla difesa del suolo (ad esempio Accordi di programma Ministero dell’Ambiente/Regioni) interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico.
Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno valutare la realizzazione da parte delle amministrazioni comunali di un efficiente sistema locale di protezione civile, in primo luogo attraverso la redazione e l’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali d’emergenza.
è l’indagine di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile realizzata per conoscere la condizione attuale dei comuni italiani in cui siano presenti aree classificate a rischio idrogeologico. Quest’anno Operazione Fiumi 2011, la campagna d’informazione per la prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico, giunta alla IX edizione è realizzata nell’ambito di un più ampio progetto, denominato appunto Ecosistema rischio che focalizza l’attenzione su alcuni dei rischi naturali ed antropici a cui è esposto il territorio della Penisola. potenziale rischio idrogeologico più alto, aree perimetrate nei piani straordinari approvati e nei piani stralcio per l’assetto idrogeologico predisposti, adottati o approvati. corretta pianificazione, gli interventi di delocalizzazione di abitazioni e altri fabbricati dalle aree a rischio, nonché nell’adeguamento alle norme di salvaguardia dettate dalla pianificazione di bacino e la manutenzione delle sponde dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche piani di emergenza – che devono essere aggiornati e conosciuti dalla popolazione, perché sappia esattamente cosa fare e dove andare in caso di emergenza – nonché nell’organizzazione locale di protezione civile, al fine di garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in caso di alluvione o frana 2
Dalla rilevazione di tali parametri è stato assegnato ad ogni comune un voto (da 0 a 10) e una classe di merito conseguente. In altre parole, è stata realizzata una vera e propria classifica che tiene conto dell’azione dei comuni nella mitigazione del rischio idrogeologico.
Le classi di merito sul lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico sono state valutate in base al punteggio ottenuto dai comuni nella risposta positiva o negativa a tutti i parametri dell’indagine (insufficiente da 0 a 3,5 punti; scarso da 4 a 5,5 punti; sufficiente da 6 a 6,5 punti; buono da 7 a 9 punti; ottimo da 9,5 a 10 punti).
L’indagine vuole essere uno strumento utile non solo per valorizzare l’esperienza dei comuni più attivi, che dimostrano come una buona gestione del territorio sia possibile e che devono diventare un esempio per tutta la regione, ma vuole servire soprattutto per stimolare le amministrazioni locali ancora in ritardo. 2. L’Entità del dissesto in Campania
Secondo il report redatto nel 2003 dal Ministero dell’Ambiente e dall’Unione delle Province Italiane sono 474 i comuni della Campania in cui siano presenti aree a rischio idrogeologico l’86% del totale
Tuttavia, un nuovo e più aggiornato report redatto dal Ministero dell’Ambiente nel 2008 ha raccolto le perimetrazioni effettuate dalle diverse Autorità di Bacino che individuano
(di cui 193 a rischio frana, 67 a rischio alluvione e 214 a rischio sia di frane che di alluvioni). Tale elenco di comuni costituisce il campione della nostra indagine. zone ad elevata criticità idrogeologica in 504 comuni campani. L’estensione di tali aree esposte a rischio è pari a oltre 2.597 kmq (cioè circa il 19% della superficie dell’intera regione). Questi dati mettono in luce chiaramente la fragilità di un territorio dove bastano ormai semplici temporali, anche non particolarmente intensi, per provocare, nel migliore dei casi, allagamenti e disagi per la popolazione. Il territorio risulta ogni anno più vulnerabile rispetto al passato.
L’elevata suscettibilità al rischio e pericolo da dissesto del territorio campano va sicuramente attribuita ad alcuni aspetti predisponenti che possono a loro volta essere distinti tra indipendenti e dipendenti dalla volontà dell’uomo. Ai primi va sicuramente ascritta, oltre che l’elevata articolazione orografica del territorio, con prevalenza di rilievi (montagna 34,6%, collina 50,8%, pianura 14,7%), la presenza diffusa di coperture piroclastiche non consolidate, prodotte dall’attività storica dei Campi Flegrei e del complesso Somma Vesuvio, che ammantano soprattutto i rilievi marginali della Piana Campana (monti Lattari, di Sarno, di Caserta, Partenio e Taburno Camposauro). Agli altri appartengono tutte le tipologie di alterazioni dei suoli (taglio e incendio dei boschi), le modificazioni dei profili e degli equilibri dei versanti (attività estrattiva, infrastrutturazione viaria), l’errata collocazione degli insediamenti (occupazione di aree di pertinenza fluviale, di conoidi), nel complesso imputabili ad una inadeguata o mancata pianificazione e gestione dell’uso del suolo.
Per questo le problematiche relative al dissesto vanno gestite su due differenti ordini temporali e di competenze: nel
Questa maggior fragilità è attribuibile ad un uso del territorio che non considera le limitazioni determinate dall’assetto idrogeologico. Se osserviamo le aree vicino ai fiumi, salta agli occhi l’occupazione crescente delle zone di espansione naturale con abitazioni ed insediamenti produttivi. Gli interventi di messa in sicurezza continuano spesso a seguire filosofie tanto vecchie quanto evidentemente inefficaci. Ancora si vedono sorgere argini senza un serio studio sull’impatto che possono portare a valle, cementificazione degli alvei e alterazione delle dinamiche naturali dei fiumi. La Campania soffre in modo particolare di evidenti carenze e ritardi nella pianificazione territoriale e urbanistica, con costruzioni che sorgono in aree e su versanti troppo spesso fragili e instabili. La pesante urbanizzazione delle aree a rischio è resa ancora più grave dall’abusivismo. breve termine, operando in termini previsionali attraverso gli approcci e le strutture propri della protezione civile; nel medio-lungo termine, avvalendosi della pianificazione 3
degli interventi (materiali ed immateriali, preventivi e sistematori) e degli approcci (metodi, modalità ), predisposta dagli enti ordinariamente competenti, in primis le Autorità di Bacino.
Il primato negativo del rischio idrogeologico nel territorio campano è detenuto dalla provincia di Salerno (99% dei comuni a rischio).
Oltre a tanti piccoli comuni, anche i cinque capoluoghi di provincia campani sono considerati a rischio idrogeologico dalla classificazione del Ministero dell’Ambiente e dell’UPI.
| COMUNI A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CAMPANIA Regione | Provincia | Frana | Alluvione | Frana e alluvione | Totale | % totale comuni | |||||
| Campania | 193 | 67 | 214 | 474 | 86% | ||||||
| AV | 80 | 8 | 17 | 105 | 88% | ||||||
| BN | 39 | 4 | 32 | 75 | 96% | ||||||
| CE | 34 | 14 | 32 | 80 | 77% | ||||||
| NA | 2 | 33 | 22 | 57 | 62% | ||||||
| SA | 38 | 8 | 111 | 157 | 99% | ||||||
Campania