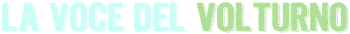Paola Paesano Se l’arte è una bufala

di Vittorio Sgarbi
Bufale. Nessuno potrebbe contestare il fatto che quella di Paola Paesano sia un’arte fatta di bufale. Non quelle metaforiche, con le quali si suole indicare, anche a sproposito o in senso strumentale, un inganno, una truffa, una cosa spacciata per ciò che non è. No, se vogliamo cercare un’arte fatta di quelle bufale ci si dovrebbe muovere in luoghi diversi da quelli battuti dalla Paesano, per esempio fra Documenta a Kassel e la Biennale di Venezia, in mezzo a galleristi, curatori e collezionisti sempre molto attenti a fare moda presso certi ambienti.
Al contrario, nel suo essere indifferente a qualunque continøenza mercantile del gusto, l’arte della Paesano è quanto di più veritiero si possa immaginare. Autentica nella genunità di un’ispirazione diretta, senza fronzoli intellettualistici che la possano inficiare, come nel piglio realistico di una rappresentazione che come primo, irrinunciabile, democratico intento ha quello di farsi capire senza che chi osservi debba essere particolarmente attrezzato per farlo.

In quanto alle bufale, quelle della Paesano sono letterali, i tipici bovini dal cui latte derivano prodotti diventati di consumo ordinario nella società globalizzata dei nostri tempi, quando una volta erano caratteristici solo di certi territori, di certe civiltà contadine. Ecco. il primo senso da attribuire all’operazione della Paesano, con tutto ciò che di provocatorio ci può essere nella proposta, assai più di quanto non si possa riscontrare in certo avanguardismo di maniera al confronto gratuito ed inconsistente, è proprio questo: provare a fare delle bufale ciò che il luogo comune, anche quello meno conformista, è solito non riconoscere, un oggetto di dignità estetica.
In qualche modo la Paesano ci invita a prendere coscienza della schizofrenia di massa a cui un certo consumismo odierno, anche quello più politicamente corretto, ci induce: la mozzarella è bella, nella sua sferoidale immacolatezza, buona, nel sapore corposo e nella sanità dell’abitudine alimentare, ma tutto ciò da cui proviene, le bestie allevate, le condizioni igieniche in cui versano, diverse dagli standard urbani considerati più evoluti, il lavoro faticoso degli allevatori vanno scavalcati a pie’ pari quasi che non esistessero, come se i latticini così graditi ai nostri contemporanei provenissero dall’alto dei cieli e non dalla terra, subito pronti a essere confezionati e disponibili ai nostri acquisti. Un’aberrazione fuori da qualsiasi logica, che non aveva ragione di essere quando le mozzarelle rientravano nei costumi solo di certe zone in cui si sapeva benissimo da dove trovassero origine. La stessa assurdità percepibile nelle anime belle che, ammirando incondizionatamente le vestigia millenarie di Paestum, si lamentano del fatto che la loro visione venga accompagnata, a seconda di come soffi il vento, dagli olezzi dei vicini allevamenti di bufale. E’ gente che crede di capire più degli altri, quando invece ha un’idea ristrettissima del mondo: Paestum, in quanto realtà ancora del tutto viva, non imbalsamata nel suo passato, fondata su una certa condizione economica in cui l’allevamento vaccino non conta certo meno dell’archeologia, è evidentemente vestigia millenarie e olezzo di bufale alla stessa maniera, senza alcuna contrapposizione. Anzi, profumo di bufale, come recitava l’accorto titolo di una mostra recente della Paesano, stavolta meno provocatoriamente di quanto possa sembrare, perchè se è vero che anche gli odori rientrano nel campo dell’umanamente opinabile, ovvero della loro elaborazione mentale, non c’è nulla che di per sè possa essere ritenuto sgradevole.
Se la nostra mente, sulla base di un ragionamento votato a valorizzare qualcosa nella positività di tutti i suoi aspetti, riesce a condizionare i sensi in modo tale che il principio di partenza trovi una sua corrispondenza estetica, allora non solo le bufale possono piacere ai nostri occhi, ma anche le loro emanazioni olfattive possono essere apprezzate dalle nostre narici.

Sarà il caso di ricordare, per dire di come possano essere le mentalità a determinare l’interpretazione di quanto i sensi registrano, che in epoche “preigieniche”, quando cioè, prima del secondo Ottocento, la sanificazione personale e ambientale non venivano ancora concepite come profilassi fondamentale per la prevenzione della malattie, l’odore beluino della carne poco lavata (la puzza, diremmo oggi tout court) era il più potente afrodisiaco avvertito nei rapporti interpersonali, responsabile degli amplessi più repentini e improbabili anche al di fuori di quelle che potevano essere le convenzioni sessuali del momento, fra nobili e popolani, per esempio, oppure fra giovani e anziani, per non dire fra uomini e animali.
Nella “guapparia” napoletana essere “fetenti”, alla lettera puzzolenti, rifiutando l’igienismo ormai praticato dalla buona società che poteva essere ammesso solo per le donne, era considerato motivo di ammirazione, in quanto indicante particolare baldanza virile, compresa quella che sfociava nella delinquenza.
Ma torniamo al centro del discorso, la Paesano e l’oriøinalità della sua proposta artistica. Bisogna chiarirlo subito: se è arrivata a concepirla in un certo modo non è per intuito astratto, come se si fosse trovata a maneggiare una certa materia per semplice simpatia, magari senza averne troppa dimestichezza.
ln realtà , l’arte della Paesano è l’appendice espressiva, il campo sentimentale in cui riversare ciò che non trova spazio altrove, di quella che è la sua effettiva professione di appartenenza. Dicono di Cèline, probabilmente a ragione, che non sarebbe potuto essere l’enorme scrittore che è stato se non fosse stato anche un medico. Si parra licet, non c’è dubbio che la Paesano artista non esisterebbe se alla radice non vi fosse un altro medico (o si deve dire una medicessa? Cosa dice a riguardo il bon ton femminista?), stavolta veterinario.

La Paesano dipinge ciò che conosce a menadito, ma non certo per esibire la sua sapienza in materia. Dipinge, semmai, per conoscere ulteriormente, sotto una luce diversa da quella che gli aspetti più freddi e burocratici del suo mestiere le
imporrebbero. Dipinge perchè ciò che crea sia rivelatore di un rapporto diverso con quello che è solitamente l’oggetto delle sue valutazioni mediche, un rapporto emotivamente coinvolto, quanto più paritetico possibile. E dal modo in cui si sforza di leggere quelli che negli umani chiameremmo volti, di interpretare in chiave affettiva pose e movimenti non solo di bufale, ma anche di altro bestiame da stalla e da aia, di associare la loro visione, in modo anche ironico, ma mai dissacratorio, a noti passi letterari in lingua napoletana, si direbbe che la Paesano, più che un veterinario, sia una psicologa degli animali.
E’ possibile concepire una psicologia degli animali? Si dovrebbe dimostrare l’esistenza negli animali di una psiche paragonabile in qualche modo a quella degli umani, chi ci riuscisse avrebbe il Premio Nobel garantito. Nessuna difficoltà , invece, a concepire una psicologia per coloro che amano fortemente gli animali. I quali non hanno bisogno di alcuna dimostrazione per provare ciò che loro dicono di avvertire a pelle: sì, anche gli animali possiedono una sostanza interiore. Forse più oscura, meno articolata nei suoi meccanismi, ma in fondo non troppo lontana dalla nostra, al punto che possiamo benissimo scorgerla nel modo in cui si mostrano a noi, esattamente come ci capita di fare con i nostri simili. E se possiamo intuire, guardandoli, la loro bontà di fondo, deve essere un nostro impegno morale ripagarli con i sentimenti nel modo in cui meritano. Mi accorgo che sto parlando della Paesano come farei di un’altra artista animalista sua precorritrice, la pittrice ottocentesca Rosa Bonheur. Instancabile frequentatrice di fiere di bestiame, dove spesso e volentieri individuava i suoi modelli, i bovini in prima fila, e li ritraeva riservando loro lo stesso rispetto, la stessa comprensione, lo stesso trasporto interiore che si era soliti rivolgere agli umani, cosa che non era per nulla scontata in quell’epoca, raccogliendo in questo senso l’eredità di un apparente omonimo, il seicentesco Rosa da Tivoli, che in realtà era un maschio (Philipp Peter Roos).

Non so se la Paesano conosca la Bonheur e ne abbia fatto motivo di ispirazione, conterebbe relativamente. Ciò che noterei, piuttosto, è che la Bonheur, personaggio libero e anti-conformista come pochi altri del suo tempo (non gradiva vestirsi da donna e non nascondeva le sue relazioni amorose con persone del suo stesso sesso) è stata considerata anche in arte una femminista ante litteram, come se il suo modo di interpretare il regno animale fosse figlio di una sensibilità speciale, non concepibile in maniera analoga nell’ambito della mascolinità . Potremmo dire lo stesso anche della Paesano? Possiamo sostenere, cioè, che la sua arte non sarebbe non solo se lei non fosse veterinario, ma anche se non fosse donna? E che il modo in cui sente il suo rapporto con il mondo animale, rivelatoci attraverso l’espressione artistica, costituisca una peculiarità altamente significativa non solo del suo essere donna, ma dell’essere donna in un senso più complessivo?
E’ un’ipotesi suggestiva, con i suoi lati anche convincenti, che lascio però aperta alle valutazioni della diretta interessata e dei lettori.
Per quanto mi riguarda, credo sia venuto il momento di concentrarsi sugli aspetti più prettamente tecnici dell’arte della Paesano, quelli per i quali, immagino, sia stato invitato principalmente a scrivere. Due i versanti battuti, non propriamente interscambiabili fra loro, anzi, almeno in parte complementari, capaci di integrarsi l’uno con l’altro. Da una parte una pittura dalle stesure larghe e in prevalenza piatte, realistica, ma non fino al punto di cercare la mimèsi quanto più aderente, essendo più orientata a soluzioni di efficace sintesi grafica, fra disegni dai contorni netti, cromìe robuste e luminescenze talvolta dispiegate come fossero filamenti di neon, i cui esiti potrebbero anche ricordare certe disposizioni della Pop Art, in una salsa naturalmente di afflato campagnolo. Dall’altra una scultura di dimensioni ridotte, in terracotta dipinta, che arriva dove la pittura lascia ancora liberi di muoversi, ricercando maggiormente il proposito imitativo, anche se secondo toni che all’accademico preferiscono di certo il popolaresco, e conferendo maggiore equilibrio realistico al rapporto fra volumetria e colore. Una scultura che, specie nelle
occasioni in cui organizza insiemi coordinati fra elementi a tutto tondo, piani di appoggio e sfondi dipinti, riporta subito alla mente certa delizie della ceroplastica sei-settecentesca, a me assai gradite, con le statuine, non solo di presepi, le loro manifestazioni più conosciute, che agiscono entro scenari racchiusi da teche o in diorami a illuminazione variabile.
In pittura come in scultura, nulla di «naif come a tavolino ci si sarebbe potuto anche aspettare traspare nel’arte meditata e manualmente ben educata della Paesano, nulla di primitivo rurale come potremmo riscontrare, per esempio, in un altro animalista quale Ligabue, cosa che indurrebbe a credere che anche le riflessioni alla base delle sue espressioni derivino da un approccio pensato, per niente impulsivo o che venga troppo condizionato dai moti incontrollati dell ‘inconscio»
Insomma, chi si fosse fatta l’idea che quella della Paesano sia solo rustica bizzarria dovrà ricredersi, così come ho provato a fare anch’io attraverso questo scritto, magari unendosi a lei nell’ode alla bovina grandezza. T’amo, o pia bufala; e mite sentimenti di vigore e di pace al cor infondi, solenne come un monumento.