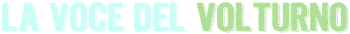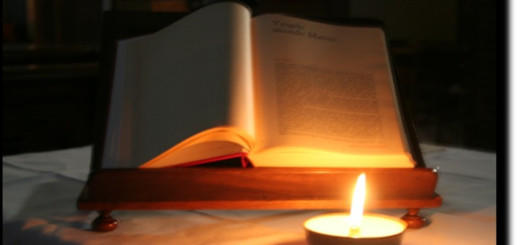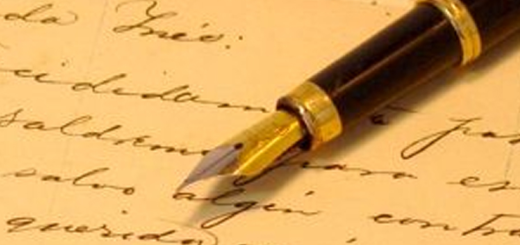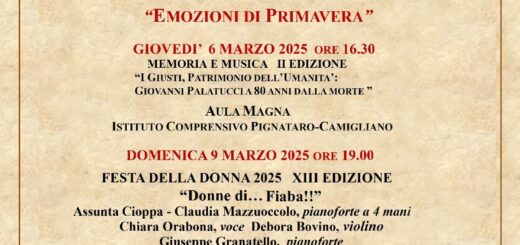L’ECONOMIA DIVINA È DIVERSA DALLA NOSTRA! (Mc 12,38)

11 novembre 2018Â – Domenica XXXII TO (B)
L’ECONOMIA DIVINA È DIVERSA DALLA NOSTRA! (Mc 12,38)
a cura del Gruppo biblico ebraico-cristiano
השורשי× הקדושי×
Prima lettura: La farina e l’olio non vennero meno (1Re 17,10). Seconda lettura: Cristo si è offerto una sola volta per tutti (Eb 9,24). Terza lettura: Quella vedova ha dato tutto quello che aveva (Mc 12,38)
- La liturgia di questa domenica ci presenta due vedove: quella di Sarepta, che rinuncia al suo cibo per aiutare il profeta Elia; e quella del vangelo, che offre i suoi due spiccioli, tutto quanto aveva per vivere. La loro generosità è ancora più nobile, se confrontata con l’atteggiamento dei ricchi, con l’empia regina Izevèl che vive nel lusso, con gli scribi che “divorano le case delle vedove†(12,40). L’antitesi ricchi/poveri serve per annunciare la novità del regno, il capovolgimento che Dio opera nella storia, ma attenzione: non basta essere vedove per andare in paradiso, né essere ricchi per andare all’inferno. Il Signore non guarda lo stato civile, ma lo stato del cuore. Le letture sono per noi un invito a riflettere sui nostri gesti esteriori di carità : “Dare ciò che si è, più che ciò che si ha†è la regola d’oro, che qualifica le nostre relazioni umane e religiose.
Il vangelo è un imperativo, non una consolazione!
- Gesù, quando esalta la vedova di Sarepta e la contrappone ai ricchi, completa la sua polemica contro i farisei. Sarepta era una città del Libano, quindi una regione fuori Israele, straniera, con tutto ciò che questo significava per gli ebrei. Lo straniero non era neppure considerato “prossimoâ€; se vedova, peggio ancora: era una donna senza identità , senza ruolo. Questa vedova straniera riceve, a differenza di tutte le altre donne di Israele, un segno dell’amore di Dio. E’ la solita contrapposizione tra i disegni di Dio e la mentalità degli uomini. Ci interroghiamo: noi, che dobbiamo fare? Può esserci anche una forma di autoconsolazione nell’esaltare i gesti semplici. I laureati e i teologati possono anche fare un’esercitazione retorica sulla grandezza spirituale della vedova straniera, ma non direbbero mai: “E allora questa vecchietta prenda il nostro posto, ci parli, l’ascolteremo con umiltà â€. La verità è che i dotti continuano a tenersi la parola! Questa vecchietta suscita simpatia, ma non turba la loro mentalità . Questa mistificazione è frequente tra i cristiani, ecco perché la rivoluzionaria rivelazione del vangelo viene diluita, diventa elemento di stabilità : i primi restano i primi e gli ultimi restano gli ultimi; in compenso diamo loro la consolazione che Dio li preferisce e che nell’altro mondo saranno più premiati!
Il credente “ad-tendeâ€, cioè si impegna
- Il credente attende che venga l’altro mondo, ma si impegna perché questo mondo cambi, qui e ora, secondo le prospettive del vangelo. Non si limita alla compassione e all’augurio che Dio passi tra i poveri con le mani piene di regali, in versione Santa Claus o Babbo Natale, ma prepara una società in cui non ci siano i poveri. Questa esigenza è ormai recepita ufficialmente nella riflessione dei credenti, a partire dal Concilio. Oggi è possibile realizzare quanto ieri sembrava utopia, perché noi oggi abbiamo possibilità ignote ai nostri predecessori. Qualche esempio: i credenti hanno affermato, e con sincerità , che uomo e donna dinanzi a Dio sono uguali, poi però sul piano storico hanno affermato che per natura sono diversi: l’uomo è più importante della donna, la donna sposata più della non sposata, la donna con marito più della vedova. Ancora: quando Paolo rimanda lo schiavo al suo padrone con una lettera di raccomandazione, chiede al padrone rispetto per l’uomo, anche se suo schiavo, ma non mette in discussione la schiavitù. Ma quando i tempi maturano, i credenti devono impegnarsi perché si realizzi, nel corpo della storia e non nel cielo dei sogni, la santa parola di Dio. Altrimenti il vangelo resta una specie di dilettazione archeologica, che non scontenta nessuno. Il vangelo, pur non essendo un libretto di politica o un manuale di economia, resta pur sempre un progetto di vita, dentro cui collocare e giudicare tutti i progetti politici e sociali.
L’economia divina così diversa dalla nostra!
- Non usiamo con superficialità la parola “fariseo†come sinonimo di ipocrita, perché vi sono stati ottimi farisei amici di Gesù, e il pericolo dell’ipocrisia è possibile in ogni persona e in ogni religione. Gesù, dopo avere demolito questa religiosità ipocrita (momento negativo), ci mostra in positivo il ritratto del vero credente, e lo fa con il commovente bozzetto della vedova. Niente di più spregevole della donna nell’antichità , e molto di questo odio è passato dall’orfismo al pitagorismo, da Platone al cristianesimo; se poi la donna era anche vedova e con figli, allora l’emarginazione era completa. Ma a Gesù non sfugge nulla, neppure i due spiccioli di questa vedova, che è entrata per sempre nel vangelo, in questo libro dei piccoli, degli sconosciuti, degli innominati, che però sono grandi davanti a Dio. Con ironia graffiante, Gesù colpisce gli atteggiamenti boriosi di questi sacri pavoni, già definiti altrove “sepolcri imbiancati … razza di vipereâ€: parole durissime, indirizzate ai farisei di ieri e di oggi, dell’ebraismo e di ogni religione.
- La critica agli scribi fatta da Gesù non si riferisce alla loro superbia. È logico pensare che tra di loro ci siano stati individui superbi ed altri umili. Quello che Gesù critica è l’istituzione stessa, sono quegli uomini religiosi, che si credevano gli interpreti ufficiali della Legge, cioè della volontà di Dio. Ad uomini di questo tipo, rivestiti di tale dignità ed autorità , non rimaneva che sottomettersi. Per questo dovevano apparire rivestiti di paludamenti sacri, di tiare e copricapo per apparire più alti dei comuni mortali, di avere nella mano il pastorale del comando, di occupare i primi posti e ricevere il baciamano, di sentirsi chiamare eccellenza o eminenza… Quando un’istituzione religiosa si organizza in questo modo, quelli che appartengono al gruppo dei privilegiati, all’alto clero (preti, rabbini, imam….), inevitabilmente si considerano non solo con il diritto, ma anche con l’obbligo di essere inflessibili nel conservare i dogmi, le norme, i riti e le cariche che toccano solo a loro. Il contrasto è con la povera vedova che dà persino quello che ha per vivere, senza emergere né apparire, perché è una persona nella quale non ci sono carica, potere, dignità , cultura, nulla che non sia un cuore buono, pieno di umanità .
- Nel tempio di Gerusalemme c’era una stanza, detta del Tesoro, che all’esterno aveva come delle trombe, nelle quali cadevano le monete delle offerte; un sacerdote era incaricato di ricevere le offerte e di firmare una ricevuta all’offerente: una nobile gara, un’asta religiosa a chi offriva di più, tra l’ammirazione del pubblico! Lascio immaginare a voi l’ironia, la fretta, il fastidio del sacerdote davanti agli spiccioli di quella vedova. Ma qui cominciano, per i discepoli e per noi, le sorprese di questa scandalosa economia divina, i cui conti sono totalmente diversi dai nostri:
â–ª questa della ricchezza è una delle grandi e continue tentazioni: anche Gesù ne fu tentato, e tutti, “in capite et in membris†siamo invitati a riflettere su questa necessità della solidarietà ; per questo la chiesa delle origini, “quando tutti i credenti mettevano tutto in comuneâ€, resta un modello, una utopia, che non significa sogno impossibile, ma ideale normativo verso cui tendere;
â–ª donando entrambi gli spiccioli, la vedova diventa modello di generosità ; Gesù lo dice chiaro: “tutto quanto aveva per vivereâ€; la vedova avrebbe fatto bene a tenere almeno uno spicciolo per sé; se avesse chiesto consiglio a qualche prete prudente, sarebbe stata invitata a non esagerare; per fortuna la donna ha dato ascolto solo al suo cuore. È la celebrazione della fiducia, della speranza. Altro che dare ai poveri o ai terremotati i nostri avanzi, i nostri vestiti consumati, che ci permettono di rinnovare il guardaroba e di sentirci buoni in coscienza!
â–ª davanti a Dio, l’offerta della vedova avrà più valore delle generose donazioni e lasciti dei potenti e dei ricchi della terra, che ieri e oggi vogliono perpetuare il loro ricordo “umano, troppo umano†direbbe Nietzsche, facendo costruire chiese e mausolei, ospedali e ospizi con l’immancabile targa e lapide celebrativa. Donare alla chiesa, ai poveri, è un bel gesto, purché sia circondato di pudore e di silenzio: “Non sappia la tua destra … Non suonare la tromba …†(Mt 6,1). Ricordiamola questa vedova: il suo dono è insignificante, ma è un dono totale, non solo dona a Dio, ma “si dona a Dioâ€. BUONA VITA!