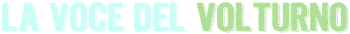LA LEGGENDA DEL KOH-I NUR, IL DIAMANTE MALEDETTO DELLO SCRITTORE CASTELLANO VITTORIO RUSSO
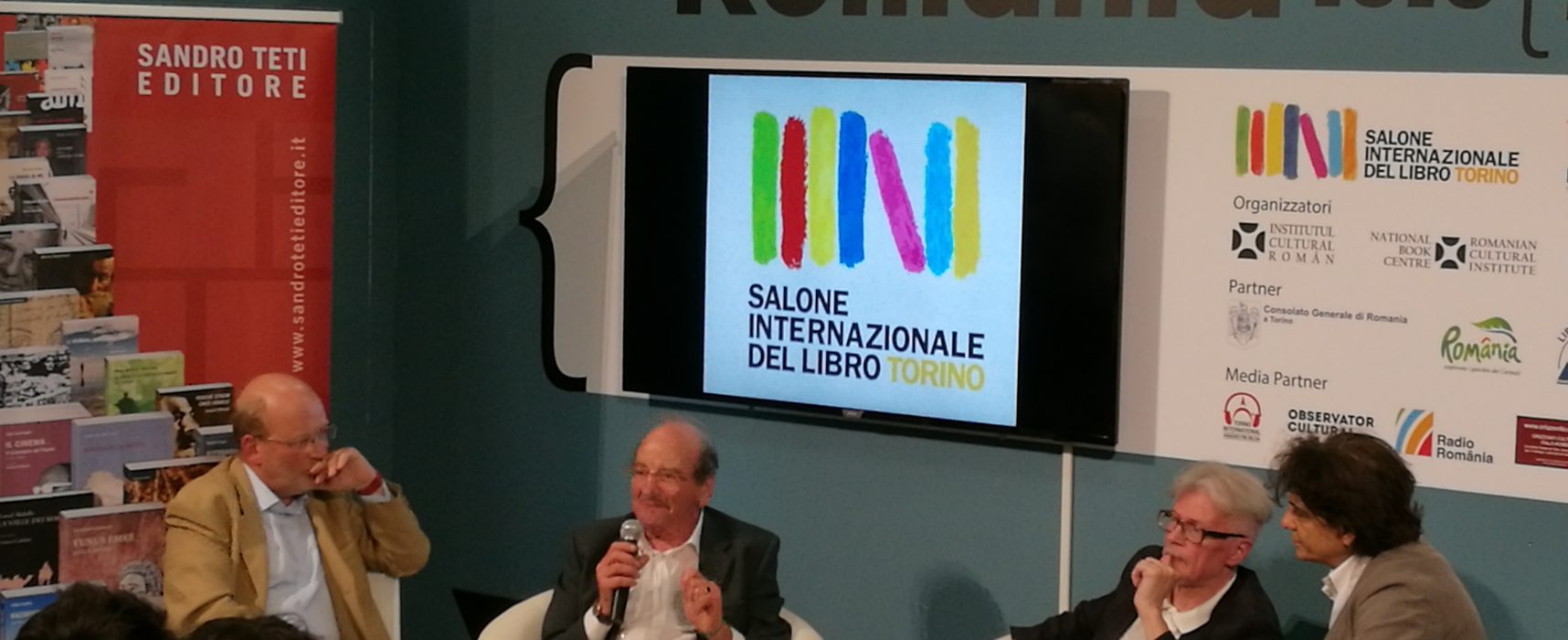
Ci sono eventi nella vita di certi oggetti che sono allegorie misteriose della parabola del destino umano forgiato dall’orgoglio dell’opulenza e della sua effimera durata. Proprio come il bagliore capriccioso che emana da un diamante. Sto parlando del Koh-i Nur, l’epica gemma fatta oggetto di qualità soprannaturali e creduta capace di assicurare al suo possessore la reggenza del mondo intero, ma anche di provocare malefici e morte. Pietra rara, di una seduzione che è come un sortilegio, il suo valore è amplificato dalle sue peripezie fra lotte cruente e trionfi folgoranti che hanno segnato l’ascesa di potenti sovrani indiani e afgani e la loro caduta rovinosa. Il suo destino è pure quello di vagare senza meta per riemergere invariabilmente nell’orizzonte di Delhi, la capitale antichissima dell’India, dove è nata e si è fissata la sua leggenda. Incerta è l’origine di questa leggenda. Si sa che la pietra era stata estratta dalle celebri miniere diamantifere dell’antica Golconda, nello Stato indiano di Andhra Pradesh in India. Si sa pure che essa esce dal buio agli inizi del 1500 con la presa di Delhi da parte del fondatore della dinastia moghul (*), Babur detto La Tigre, il cui figlio, Humayun, la ricevette in dono dal maharaja di Gwalior, divenuto suo vassallo dopo essere stato sconfitto.
Il Koh-i Nur è un diamante bianco dal peso di otto misqal, come dice un cronista di tanto tempo fa, equivalente a circa 186 carati. Forse è il più grande al mondo, ma più che i carati, è la sua luminosità eccezionale che ne ha fatto il paradigma di un’attrazione occulta e oggetto di una cieca frenesia di possesso. La leggenda sa pure che qualche anno prima ad Humayun, gravemente ammalato, era stato predetto che solo se si fosse liberato del diamante sarebbe guarito. Scettico, il sovrano non diede importanza al vaticinio, le sue condizioni però peggiorarono al punto che il padre, Babur, pregò chiedendo di morire al posto del figlio. Babur morì davvero di lì a poco e Humayun sopravvisse.
Nella sinusoide senza fine delle vicende della dinastia, Humayun, sconfitto in battaglia da un afgano pretendente al trono indiano, fuggì, si dice, senza scarpe e senza turbante, nascondendo però il diamante in qualche modo. Di esso fece dono a un sovrano persiano, Shah Tahmasp, che l’aiutò a far ritorno in India e a riconquistare l’impero. Humayun morì sfinito dagli abusi e dall’oppio o, come sostengono i fautori della leggenda, per effetto ella maledizione del Koh-i Nur. Non migliore fine fece lo shah persiano suo alleato nella riconquista dell’impero.
La gemma fece nuovamente ritorno a Delhi agli inizi del 1600 e finì nelle mani di un altro Moghul, il potentissimo Shah Jahan, dalla sovranità che sconfinava nell’apoteosi. Egli coronò il suo sogno di opulenza entrando in possesso del Koh-i Nur a prezzo di intrighi inimmaginabili, di veleno e di oro a molti carati. Ma il maleficio non tardò a colpire lui pure, come prima aveva colpito quelli che l’avevano posseduto e sfoggiato con ostentazione. Shah Jahan fu, difatti, spodestato da uno dei figli, Aurangzeb, (era la norma nella dinastia dei Moghul) e relegato in una torre del Forte Rosso di Agra, proprio di fronte al Taj Mahal, il tempio malinconico e superbo che egli aveva costruito perché accogliesse le spoglie della consorte più amata. Da quella torre, nell’aria densa di pulviscolo, il Taj Mahal appare come un disegno sfumato, una nuvola di marmo candido, sospesa quasi nella luce e nel tempo. Così lo vedeva, si dice, Shah Jahan, ombra senile di una grandezza lontana, attraverso i riflessi del Koh-i Nur che resse, splendido e inutile, nelle mani tremanti fino alla morte in quella gabbia dorata da cui non era più uscito. Di figlio in figlio la gemma finì sulla corona di un altro moghul, Muhammad Shah, ottavo imperatore della dinastia e lontano pronipote di Shah Jahan.
Nel 1739 calò dalla Persia sull’India un nuovo sovrano razziatore e vorace, Nadir Shah, che mosso dall’inveterato sogno di conquista del Paese, affrontò e vinse in battaglia l’esercito di Muhammad Shah. Ancora una volta Delhi fu ridotta in macerie e depredata delle sue ricchezze fra cui il celeberrimo Trono del Pavone. Si racconta che lo sconfitto sovrano, fatto prigioniero, avesse nascosto il Koh-i Nur nelle pieghe del proprio turbante. Segretamente informato, Nadir, adducendo a pretesto una consuetudine inventata su due piedi, chiese al vinto di scambiare i reciproci copricapi per suggellare l’armistizio. E così la gemma passò nelle mani del nuovo dominatore. Muhammad Shah sopravvisse alla sventura, ma solo per poco. Il diamante divenne noto da allora come Koh-i Nur, ovvero la Montagna di Luce. Così Nadir Shah, colpito dal suo splendore, pare avesse esclamato avendolo tra le mani. Il suo nome era fissato per sempre. Da allora si andò pure consolidando la leggenda secondo cui, nelle mani di una donna, esso sarebbe diventato un potente talismano portatore di fortuna e felicità . Avrebbe dato invece poteri sconfinati ai sovrani che l’avessero posseduto senza però mai indossarlo, pena la perdita del trono e della vita se l’avessero fatto. Proprio come era regolarmente avvenuto fin lì e come avvenne a Nadir Shah, che mori assassinato qualche tempo dopo.
Il diamante finì poi nelle mani di un altro predone afgano Ahmad Shah, succeduto avventurosamente nel 1747 a Nadir al quale lo aveva sottratto. Ahmad lo tenne da allora sempre stretto al braccio come qualcosa di sé e d’irrinunciabile, quasi uno stigma di ineluttabile maledizione. Gli fu tolto a sua volta sul letto di morte da un nipote, Shah Shuja, proclamatosi re dell’Afghanistan nel 1801. Rovesciato dal trono da uno dei fratelli, Shah Shuja si rifugiò a Delhi. Qui dopo tortuose peripezie patteggiò con il maharaja sikh del Punjab, Ranjit Singh, la propria libertà in cambio del Koh-i Nur che non aveva mai smesso di portare con sé, incastonato in un bracciale. Shah Shuja finì assassinato di lì a poco, così come il maharaja sikh che era morto anche prima di lui. L’effimero regno del Punjab di Ranjit Singh ebbe fine con la sua annessione al Raj britannico, il costituito impero anglo-indiano. Il Koh-i Nur tornava ancora inesorabilmente a Delhi, nelle mani dei nuovi signori dell’impero indiano, gli Inglesi.
Il diamante appartiene attualmente alla corona britannica da quando la East Indian Company ne fece dono alla Regina Vittoria nel 1849. È incastonato al centro della croce maltese della corona di Elizabeth Bowes-Lyon, conservata nella Torre di Londra. Non risulta che i sovrani britannici siano superstiziosi. Fino a oggi però, la gemma è stata indossata solo da regine alle quali ha portato fortuna e longevità . Sarà ancora così?
Quando lo vedi davanti a te questo diamante, nell’attimo in cui lo sfiori con lo sguardo, nella cornice del suo fascino impenetrabile, non puoi fare a meno di percorrere tutte le distanze spazio-temporali che lo hanno visto protagonista nel corso della sua storia turbinosa. Ti convinci allora che l’immortalità è il suo destino perché è nel senso del tempo che è scritto il suo divenire e quello della Delhi che verrà , la città immortale alla quale è misteriosamente legato il suo destino.
(*) – I Moghul (che significa mongolo), sono gli imperatori islamici della dinastia di Tamerlano (che vantava di discendere dal mongolo Gengis Khan), detti perciò anche Timuridi, che regnarono dal 1500 alla fine del 1700 sui vasti territori che si estendevano dall’Afganistan all’India, fino al Bengala a nord, e a sud fino al Deccan. Furono sovrani potentissimi che vissero in un’opulenza scandalosa, ma si distinsero anche per l’amore che mostrarono per le arti e la cultura, l’impegno di mecenati e l’abilità di legislatori e di condottieri di talento.