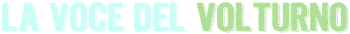COSTITUZIONE E LAVORO

di Francesco NUZZO
Un fatto di cronaca “minima†mi ha colpito nella sua arida semplicità : lo sciopero degli insegnanti diplomati, che una sentenza del Consiglio di Stato esclude dalle graduatorie a esaurimento, allontanandoli dal contratto a tempo indeterminato. La vicenda riguarda 43.600 precari con un diploma conseguito entro l’anno 2002, a partire dal quale la legge ha reso obbligatoria per i maestri la laurea in scienze per la formazione primaria. Immessi nelle graduatorie con riserva per effetto di ricorsi, seimila di essi sono stati assunti nella scuola statale.
Ora, il supremo giudice amministrativo s’è discostato da precedenti decisioni, che avevano consentito ai maestri di insegnare con la prospettiva dell’assunzione definitiva. Insomma: il diploma magistrale è abilitante all’insegnamento, ma non dà diritto a essere collocati nelle graduatorie, e dunque a ottenere un posto fisso. Cittadini che, con sacrifici incommensurabili sul piano personale e familiare, da diverso tempo, e magari avendo operato impegnative scelte esistenziali, corrono il rischio concreto di essere buttati sulla strada senza lavoro e senza domani.
Le argomentazioni giudiziali non mi interessano: magari sono anche corrette, o addirittura correttissime, per soddisfare i palati più esigenti in termini di diritto. La questione è diversa, poiché tocca assetti essenziali dell’organizzazione politica e sociale: una scandalosa situazione, da risolvere ben prima che venisse calata l’accetta del magistrato. E se c’era un problema di risorse, bastava ridurre alla fonte le indecenti spese clientelari dello Stato e degli enti territoriali, per costituire il gruzzolo necessario a pagare coloro che erano stati illusi, confidando nelle istituzioni.
Non appaiono credibili i responsabili del misfatto, quando assumono l’abito dei riformatori illuminati, e dimenticano che eventi del genere scalfiscono il grande significato del settantesimo anniversario della Costituzione. Elaborata e approvata da un’Assemblea, che per la prima volta nella storia d’Italia riunì i rappresentati di tutto il popolo, sospinto da una stessa ansia di civile rinnovamento, maturata nella tragica esperienza della dittatura e della sconfitta, quella legge suprema rappresenta una vera conquista di civiltà . Essa afferma valori razionali per l’edificazione di un “mondo umano, cioè giusto, di una giustizia realizzata con mezzi giusti, e libero, di una libertà realizzata per mezzo della libertà . Mondo umano della storia: mondo fatto dagli uomini, per gli uomini, ma umanamente, cioè rispettando l’uomo e le leggi profonde e le profonde esigenze spirituali dell’umanità â€, per dirla con il filosofo Giuseppe Capograssi, che sull’argomento ha scritto pagine mirabili.
A leggere queste parole, si intende al meglio il significato del principio fondamentale, con cui si apre il testo costituzionale, che qualifica l’Italia “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro†(art. 1). L’enunciato segna il distacco netto dagli statuti e dalle formule del passato, che offrivano un presidio intangibile a una società elitaria e articolata sulla proprietà privata dei beni di produzione, proclamata “sacra e inviolabileâ€. Viene cioè invertito il valore da attribuire ai due termini del rapporto proprietà -lavoro, conferendo la preminenza al secondo, da non intendere semplicemente come una merce, o un articolo di commercio.
Dalla Costituzione, infatti, emergono connessioni che evocano un motivo di chiara radice mazziniana: lo stretto legame tra il godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri “inderogabiliâ€, necessari a realizzare la solidarietà nel campo dei rapporti politici, economici e sociali (art. 2). In questa dimensione il lavoro costituisce un inviolabile diritto di libertà della persona, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività , e impone ai poteri pubblici l’obbligo di adoperarsi per favorire l’impiego di tutti i cittadini idonei. Ma è anche un dovere, benché prevalentemente morale: ciascuno deve svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie attitudini, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale dell’insieme, in modo da fornire un apporto concreto allo sviluppo della comunità  di cui è parte (art. 4).
Ne viene fuori l’uomo “socialeâ€: quello che si dona e riceve, mentre unisce la sua vita con la vita degli altri; dona il suo sforzo, ma riceve lo sforzo degli altri, e dall’incontro nasce una realtà più ricca e vivificata dal lievito creativo dell’essere insieme, che chiamiamo vita comune.
Alla Repubblica compete la rimozione degli ostacoli che ingombrano la strada per liberare la persona dalle condizioni, non dipendenti dalla sua volontà , che incidono negativamente sul suo sviluppo materiale, spirituale, civile, culturale, economico. In modo che siano combattuti certi “maliâ€, che si affiancano alla malattia e alla morte. Mi riferisco, anzitutto, alla disuguaglianza nei punti di partenza della vita, per cui alcuni sono avvantaggiati di tanti anni rispetto ad altri, senza alcun merito che giustifichi tale sperequazione. Poi, ci è la mancanza di lavoro, la disoccupazione, una specie di agonia che priva l’uomo della stessa speranza, spesso costretto a misurare l’importanza del bisogno, non secondo convenienti e ragionevoli preferenze, ma per l’urgenza di provvedere alla sussistenza della famiglia, con ricadute sui più deboli e indifesi.
Ecco le immediate considerazioni, che mi sono venute al pensiero di uno sciopero a sostegno di una pretesa sacrosanta.