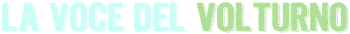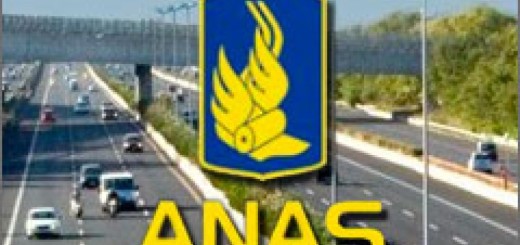Cancello ed Arnone-INCONTRO DI LETTERATITUDINI DEL MESE DI APRILE 2011
Questa serata è stata nuovamente dedicata a Pier Paolo Pasolini, indubbiamente un uomo – poeta – scrittore – regista del quale non si può parlare in un unico incontro, anzi ci vorrebbero ore ed ore per riuscire a comprendere, almeno in parte, questo grandissimo personaggio.
In questo meeting abbiamo sviluppato le tematiche riguardanti la sua infanzia e la sua fanciullezza trascorsa in Friuli.
Egli nasce a Bologna il 5 marzo 1922, primogenito di Carlo Alberto Pasolini, tenente di fanteria, e di Susanna Colussi, maestra elementare. Il padre, di vecchia famiglia ravennate di cui ha dissipato il patrimonio sposa Susanna nel dicembre del 1921 a Casarsa. I due sposi si trasferiscono in seguito a Bologna.
“Sono nato in una famiglia tipicamente rappresentativa della società italiana: un vero prodotto dell’incrocio… Un prodotto dell’unità d’Italia. Mio padre discendeva da un’antica famiglia nobile della Romagna, mia madre, al contrario, viene da una famiglia di contadini friulani che si sono a poco a poco innalzati, col tempo, alla condizione piccolo-borghese. Dalla parte di mio nonno materno erano del ramo della distilleria. La madre di mia madre era piemontese, ciò non le impedì affatto di avere egualmente legami con la Sicilia e la regione di Romaâ€.
A Bologna la famiglia Pasolini resta poco: si trasferiscono a Parma, Conegliano, Belluno, Sacile, Idria, Cremona, ancora Bologna ed altre città del nord.
“Hanno fatto di me un nomade. Passavo da un accampamento all’altro, non avevo un focolare stabileâ€.
Nel 1925, a Belluno, nasce il secondogenito, Guido.
Visti i numerosi spostamenti, l’unico punto di riferimento della famiglia Pasolini rimane Casarsa.
Pier Paolo vive con la madre un rapporto di simbiosi, mentre si accentuano i contrasti col padre.
“Tutte le sere aspettavo con terrore l’ora della cena sapendo che sarebbero venute le scenate […] In me c’era una iniziale rimozione della madre che mi ha procurato una nevrosi infantile. Questa nevrosi mi aveva fatto diventare inquieto, di un’inquietudine che metteva in discussione in ogni momento il mio essere al mondo. […] Quando mia madre stava per partorire ho cominciato a soffrire di bruciori agli occhi. Mio padre mi immobilizzava sul tavolo della cucina, mi apriva l’occhio con le dita e mi versava dentro il collirio. E’ da quel momento simbolico che ho cominciato a non amare più mio padre.â€
Riferendosi alla madre:
“Mi raccontava storie, favole, me le leggeva. Mia madre era come Socrate per me. Aveva e ha una visione del mondo certamente idealistica e idealizzata. Lei crede veramente nell’eroismo, nella carità , nella pietà , nella generosità . Io ho assorbito tutto questo in maniera quasi patologicaâ€.
Con il fratello Guido vive un rapporto di amicizia. Il fratello minore vive in una sorta di venerazione per il maggiore: bravo nello studio e nei giochi con gli altri ragazzi. Questa ammirazione accompagnerà Guido fino al giorno della sua morte.
I primi anni di scuola sono compiuti tra innumerevoli trasferimenti che, comunque, non intaccano il rendimento scolastico di Pier Paolo. Frequenta la scuola elementare con un anno d’anticipo. Nel 1928 è l’esordio poetico: Pier Paolo annota su un quadernetto una serie di poesie accompagnate da disegni. Il quadernetto, a cui ne seguirono altri, andrà perduto nel periodo bellico.
Ottiene il passaggio dalle elementari al ginnasio che frequenta a Conegliano.
Di quegli anni il passo noto come Teta veleta, che Pasolini più tardi spiegherà in questo modo:
“Fu a Belluno, avevo poco più di tre anni. Dei ragazzi che giocavano nei giardini pubblici di fronte a casa mia, più di ogni altra cosa mi colpirono le gambe soprattutto nella parte convessa interna al ginocchio, dove piegandosi correndo si tendono i nervi con un gesto elegante e violento. Vedevo in quei nervi scattanti un simbolo della vita che dovevo ancora raggiungere: mi rappresentavano l’essere grande in quel gesto di giovanetto corrente. Ora so che era un sentimento acutamente sensuale.
Se lo riprovo sento con esattezza dentro le viscere l’intenerimento, l’accoratezza e la violenza del desiderio. Era il senso dell’irraggiungibile, del carnale – un senso per cui non è stato ancora inventato un nome. Io lo inventai allora e fu “teta veletaâ€. Già nel vedere quelle gambe piegate nella furia del gioco mi dissi che provavo “teta veletaâ€, qualcosa come un solletico, una seduzione, un’umiliazioneâ€.
Lo stesso Pasolini preciserà :
“La mia infanzia finisce a 13 anni. Come tutti: tredici anni è la vecchiaia dell’infanzia, momento perciò di grande saggezza. Era un momento felice della mia vita. Ero stato il più bravo a scuola. Cominciava l’estate del ’34. Finiva un periodo della mia vita, concludevo un’esperienza ed ero pronto a cominciarne un’altra. Questi giorni che hanno preceduto l’estate del ’34 sono stati tra i giorni più belli e gloriosi della mia vitaâ€.
Pier Paolo conclude gli studi liceali e a 17 anni si iscrive all’Università di Bologna, facoltà di lettere. Negli anni del liceo crea, insieme a Luciano Serra, Franco Farolfi, Ermes Parini (di cui Guido Pasolini prenderà a prestito il nome, Ermes, per la sua militanza partigiana nella Osoppo), Fabio Mauri, ad un gruppo letterario per la discussione di poesie. Collabora a “Il Setaccioâ€, il periodico della Gil bolognese. In questo periodo Pasolini scrive poesie in friulano e in italiano, che saranno raccolte in un primo volume, Poesie a Casarsa. Partecipa poi alla redazione di una rivista, “Stroligutâ€, con altri amici letterati friulani, con cui ha creato la Academiuta di lenga furlana. Il dialetto rappresenta una sorta di opposizione al potere fascista:
“Il fascismo non tollerava i dialetti, segni / dell’irrazionale unità di questo paese dove sono nato / inammisibili e spudorate realtà nel cuore dei nazionalisti /â€
L’uso del dialetto rappresenta anche un tentativo di privare la Chiesa dell’egemonia culturale sulle masse sottosviluppate.
Mentre la sinistra predilige infatti, l’uso della lingua italiana, e se si eccettuano alcuni sporadici casi del giacobinismo, l’uso dialettale è stata una prerogativa clericale, Pasolini tenta appunto di portare anche a sinistra un approfondimento in senso dialettale della cultura.
Il ritorno a Casarsa rappresenta, negli anni dell’università , il ritorno ad un luogo felice per Pasolini. Scrive a Silvana Ottieri in una lettera dell’aprile 1947:
“Che si fosse di sabato Santo era un particolare che mi lasciava freddo. Tu avessi visto i colori dell’orizzonte e della campagna! Quando il treno si fermò a Sacile, in un silenzio fittissimo, da ultima Tule, ho sentito di nuovo le campane. Là , dietro alla stazione di Sacile si spiegava verso la campagna una strada che non so se ho percorso durante l’infanzia o se ho sognato…â€
Mi piacerebbe continuare a raccontare l’avvincente storia di Pier Paolo Pasolini, ma sono certa che perderei l’attenzione di qualsiasi lettore, perché ritengo che ognuno debba predisporsi per proprio conto all’apprendimento di nozioni ed informazioni da qualsiasi parte provengano.
Ma permettetemi di segnalarvi questo passo tratto da: Matteo Cerami e Mario Sesti “La voce di Pasolini – i testi, Feltrinelli Real Cinema, 2006.
“Il capitalismo è oggi il protagonista di una grande rivoluzione interna: esso sta evolvendosi, rivoluzionariamente, in neocapitalismo. […] Davanti a questo neocapitalismo rivoluzionario, progressista e unificatore si prova un inaudito sentimento (senza precedenti) di unità del mondo.
Perchè tutto questo? Perché il neocapitalismo coincide insieme con la completa industrializzazione del mondo e con l’applicazione tecnologica della scienza. Tutto ciò è un prodotto della storia umana: di tutti gli uomini, non di questo o quel popolo. E infatti i nazionalismi tendono, in un prossimo futuro, a essere livellati da questo neocapitalismo naturalmente internazionale. Sicchè l’unità del mondo (ora appena intuibile) sarà un’unità effettiva di cultura, di forme sociali, di beni e di consumi.
Io spero naturalmente che, nella competizione che ho detto, non vinca il neocapitalismo: ma vincano i poveri. Perché io sono un uomo antico, che ha letto i classici, che ha raccolto l’uva nella vigna, che ha contemplato il sorgere e il calare del sole sui campi, tra i vecchi, fedeli nitriti, tr i santi belati; che è poi vissuto in piccole città dalla stupenda orma impressa dalle età artigianali, in cui anche un casolare o un muricciolo sono opere d’arte, e bastano un fiumicello o una collina per dividere due stili e creare due mondi. (Non so quindi cosa farmene di un mondo unificato dal neocapitalismo, ossia da un internazionalismo creato, con la violenza, dalla necessità della produzione e del consumo).
A cura di Matilde Maisto
Â
(Da sx Arkin Jafuri, Matilde Maisto, Felicetta Montella, Maisto Mena, Marinella Viola, Raffaele Raimondo, Laura Sciorio)