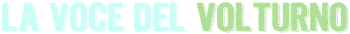“SULLE ALI DEL MITO” DI VITTORIO RUSSO

SECONDA PUNTATA
L’Odeion ne è la testimonianza più celebre. Un gemma preziosa, ancora oggi è viva in tutto il suo splendore perché vi si rappresentano seguitissimi spettacoli.
La strada pedonale Dionissiou Areopagitou prosegue verso nord-ovest per diventare un viale nella parte prospiciente l’ingresso all’Acropoli. A sinistra si estendono i resti dell’Antica Agorà . È veramente difficile non perdersi nei meandri di cento vie, tutte uguali. Raggiungere l’entrata delle rovine e stata un’impresa. Dopo aver chiesto informazioni a sette ateniesi autentici, tutti però incapaci di darmi una risposta, stranezza della vita, una ragazza austriaca mi ha tratto d’impaccio con le opportune indicazioni. Aveva vissuto la mia stessa esperienza di confusione il giorno prima.
L’Agorà era il luogo di ritrovo degli antichi ateniesi e il centro della vita commerciale e amministrativa della città . Raggiunse il massimo splendore ai tempi di Pericle e lo conservò per secoli per poi gradatamente smarrirlo, fino a quando fu distrutta dagli Eruli. Proprio in questo spazio che ho percorso con passo frenetico sotto un sole rabbioso, Socrate esponeva sereno il suo pensiero. E sempre qui, Paolo di Tarso se ne venne a predicare il messaggio di Cristo risorto. L’ampia distesa, che un tempo ferveva di vita, dominata dalla Stoà di Attalo, ora è disseminata di rovine. La Stoà è una lunga galleria coperta voluta da Attalo I, re di Pergamo. Qui, tra negozi alla moda e bancarelle dai colori vivaci, avevano luogo incontri e si socializzava. La Stoà è stata restaurata di recente con non poche libertà e secondo una discutibile interpretazione architettonica. I restauri si devono all’American School of Archaeology che di fatto hanno modificato le strutture e operato cambiamenti di pessimo gusto. La facciata, che era originariamente di un intenso colore rosso, è coperta ora di uno sfavillante marmo bianco così come il pavimento di orribile gress grigio e scivoloso. Ancora più vistose sono le colonne doriche e ioniche che sostengono il piano superiore e il tetto, di un bianco asettico e glaciale.
All’estremità nord occidentale dell’Agorà sorge maestoso l’Efèsteion, il tempio dorico di Efesto, il dio dei fabbri le cui botteghe e fonderie correvano tutto intorno. Anche questo tempio, progettato da Ictino, uno degli architetti del Partenone, si deve all’infaticabile impegno di Pericle. La costruzione si erge sulla sommità di una collinetta che diventa la ripida pendice di un invalicabile montagna se scalata sotto il sole, come è capitato a me. L’ultimo scalino di roccia dell’interminabile ascesa mi ha tratto dal petto un sospiro di sollievo. È stato un sospiro così profondo che ha mosso il sorriso di un gruppo di turisti spagnoli e distratto forse, nel silenzio della sua cella ideale anche lo zoppo dio dei fabbri.
Per rieducare il respiro credo di aver indugiato all’ombra del tempio per un tempo lunghissimo, abbastanza per coinvolgermi involontariamente in uno scambio divertente tra una robusta turista canadese e uno dei guardiani che esprimeva giudizi aspri e definitivi su Dabbeliubosh (così pronunziava il nome di George W. Bush), sulla politica americana, sulla guerra in Iraq e sulla lobby giudaica… A quest’ultimo riferimento la donna ha avuto un sussulto. Si è capito che era di origini ebraiche. È scappata via senza profferir parola lasciando il guardiano di stucco: la sigaretta appesa sul labbro inferiore e gli occhi acquosi levati al cielo per la meraviglia.
Dall’Antica Agorà ho raggiunto l’Agorà Romana, che si trova poco lontana, a est, di fronte alla Biblioteca di Adriano. Appena superato l’ingresso, mi sono trovato davanti l’imponente Torre dei Venti, bianca nei suoi marmi tersi e molto ben conservata. Essa è detta pure Orologio di Kirrestos perché concepita da un astronomo di nome Andronìco, originario di Kirros. Si tratta di un monumento a sezione ottagonale che risale al I sec. a.C. Fungeva allora da indicatore dei venti, delle direzioni cardinali, ma anche da orologio ad acqua. In seguito, fu adibito a chiesa e, durante l’epoca di dominazione turca, divenne perfino monastero di dervisci, che erano membri di una confraternita islamica celebri per il loro danze mistiche.
Dell’Agorà Romana propriamente detta non resta praticamente nulla. A uno sguardo superficiale il sito appare poco più che un cumulo di rovine, di frammenti di marmo e di capitelli spezzati. Davanti a queste spoglie gloriose tutto deve essere immaginato. L’ampio spazio era circondato un tempo da un’altra stoà . Questa pure era coperta e sostenuta da colonne doriche. Si sviluppava lungo il lato nel quale si apre la porta occidentale, ossia il Propilèo dedicato ad Atena Archegètis. Sul lato a levante, invece, le colonne sono di ordine ionico. Quest’Agorà fu costruita dai Romani intorno al I sec. a.C. quando fu deciso di trasferire il centro commerciale dall’antica Agorà in questo nuovo sito. Fu abbellita successivamente dall’infaticabile Adriano, costantemente innamorato della città e della sua arte, che ne dispose la pavimentazione di cui però non restano che vaghe tracce. Anche quest’opera fu distrutta dagli Eruli nel III secolo d.C. In seguito lo spazio fu occupato da case private, botteghe, chiese e perfino da una moschea.
Poco a ponente dell’Acropoli si leva, verde e ingobbita, la collina dell’Areopago. Prende il nome da Ares, dio della guerra, che stando al racconto mitico qui fu processato per un suo misfatto. Da allora fu sede di un tribunale che giudicava solo crimini di sangue. Divenne in seguito la sede del tribunale supremo di Atene il cui prestigio non scemò nemmeno con l’avvento dei Romani. Qui predicò Paolo che vi convertì Dionigi, primo vescovo di Atene, conosciuto come l’Areopagita al quale è intitolata la strada di cui ho accennato e una splendida chiesa cattolica, non lontana dall’Accademia.
Proseguendo lungo l’Ermou, l’arteria che collega la piazza Syntagma con quella di Monastiraki, sono giunto al Kerameikos, il Ceramico, quello che un tempo era il quartiere dei vasai. Esso si estendeva tra le due porte più importanti di Atene: quella di Dypilon e la porta detta Sacra. Quest’ultima immetteva proprio nella Via Sacra, la stessa che i pellegrini provenienti da Elèusi, a ponente di Atene, percorrevano per entrare in città . Dalla porta di Dypilon, invece, partiva la processione panatenaica che si recava sull’Acropoli. Nel tempo, la Via Sacra divenne anche la Via delle Tombe a motivo delle sepolture dei personaggi più eminenti della città qui sepolti. Alcune delle steli dei monumenti tombali sono conservate nel Museo del sito, presso l’ingresso, altre nel Museo Archeologico. Celebre è quella dell’ultimo addio di una madre al proprio figlio, caratterizzata, oltre che dalla stretta di mano consueta, da una delicatissima carezza della mano materna su una guancia del bambino. Esprime una sensibilità artistica delicatissima che meriterebbe una ben più densa descrizione.
Ho visitato il Museo Archeologico Nazionale subito dopo un pasto leggero a base di vari antipasti: i comunissimi keftedes, che sono delle polpettine di carne di agnello o di maiale, i saganaki, tocchetti di formaggio duro e piccante fritti fino a diventare croccanti, il tzatziki, una crema di yogurt denso con aglio, olio e cetrioli, senza dimenticare il saporitissimo tsiros che è uno sgombro essiccato, cotto alla griglia e condito con abbondante aceto e olio.
Il Museo Archeologico di Atene accoglie, come quello di Napoli, la più prestigiosa raccolta di ritrovamenti dell’antichità classica. Qui sono esposte le testimonianze più celebri della storia cinque volte millenaria della Grecia. Testimonianze che vanno dai resti della civiltà cicladica, a quella minoica, a quella micenea e a quelle della Grecia classica e dell’Ellenismo dei tempi posteriori ad Alessandro. Con rammarico ho appreso che le sale al primo piano, contenenti la raccolta degli affreschi minoici di Akrotiri a Santorini, sono tuttora chiuse per restauri.
Ho trovato interessantissima la collezione dei reperti preistorici risalenti al neolitico e all’età del bronzo delle civiltà egèe. Si tratta di pezzi unici, alcuni dei quali risalgono addirittura al VII millennio a.C. Né meno ricca è la raccolta di sculture antiche. Tra esse, eccezionali, sono quelle più arcaiche dei kouroi e delle korai. Sono questi gli esempi più tipici di statuaria del periodo antico (risalgono al VII sec. a.C.) e rappresentano giovani uomini nudi e ragazze avvolte in pepli, a figura intera e a vista frontale. I kouroi, in particolare, che richiamano le sculture egizie per la fissità della posa, sono stilizzazioni di giovani con la gamba sinistra avanzata rispetto all’altra e i tratti del volto caratterizzati da un indecifrabile sorriso. Le korai, invece, testimonianza della scultura della stessa epoca, raffigurano fanciulle avvolte in un peplo essenziale, con pieghe appena accennate. Esse pure sono concepite, come i kouros, per una visione frontale.
L’abbondanza degli oggetti e il loro interesse avrebbero comportato una visita più prolungata di quella da me programmata. Ho avuto la fortuna d’incontrare un gruppo di turisti francesi nel quale mi sono infiltrato. Dal declamare di tiritera, tipico delle guide che hanno appreso a memoria le cose da dire, mi sono fatto un’idea delle opere raccolte nella sezione dedicata alla collezione dei vasi del periodo detto “geometricoâ€. Esso è stato così denominato per le linee e i tratti dipinti, o meglio scalfiti, sui vasi di epoca arcaica. Se avessi voluto leggere tutte la targhe e le descrizioni relative a ciascuno di essi, avrei speso delle ore.
Un tempo più lungo ho dedicato invece alla raccolta delle antichità micenee, provenienti dagli scavi di Micene, e in particolare alle splendide maschere d’oro, tra cui quella detta di Agamennone, scoperta di Schliemann. Altrettanto superbe sono le raccolte custodite nella sezione dei bronzi, sicuramente unica per l’eccezionalità dei reperti esposti. Tra essi, un possente Cronide nell’atto di scagliare forse un tridente, se deve identificarsi con Poseidone, o forse un fulmine, nel caso si trattasse invece di Zeus. La splendida opera fu rinvenuta a Capo Artemisio e con il nome di Poseidone di Artemisio (ma anche Zeus di Artemisio) è oggi universalmente conosciuta.
Ho lasciato il Museo con gli ultimi visitatori all’ultima ora e con gli occhi ancora luccicanti per le tante meraviglie che in essi avevo fissato.
Me ne sono andato in giro per le strade di Plaka dove ho cenato e bevuto dell’ottimo vino aromatizzato con un gruppo di studenti con i quali mi sono intrattenuto a discutere, soprattutto di politica. È questo l’argomento che i greci amano dibattere di più. Lo fanno con vivacità e certezza di opinioni che esprimono in maniera categorica. Mi è piaciuto l’orgoglio di questi ragazzi che alzano la fronte e dicono senza complessi quello che pensano.
Di buon’ora il telefono ha preso a squillare per svegliarmi a un giorno che per me, ansioso, era già iniziato due ore prima. Oggi ho programmato una visita a Tebe e a Delfi. Con un piccolo pullman siamo partiti, io e gli altri escursionisti, alle sei e quarantacinque, puntualissimi. Albeggiava appena, ma fuori, già ardito, il vento consueto di nord-est, riempiva le bandiere greche su tutti i davanzali stendendone nel blu smorto dell’alba le strisce azzurre. A farci da guida era una ragazza con cui ho stretto amicizia, Laurentìa Ghianola, così ha detto di chiamarsi pronunziando male in italiano il suo nome, che poi è Lorenza Giannola, di origini venete non molto remote. Il gruppo dei turisti, sei in tutto, era formato da due coniugi giapponesi dai tratti consueti, forse quarantenni forse sessantenni, chissà , bassi entrambi, il volto maculato di grigio e di ocra, gli occhi assonnati tipici dei volti con la plica mongolica e i capelli ispidi, quelli di lui, come crini di zebra. C’era poi una trentenne canadese, Wendy, più fumante dell’Etna e schizzante di un entusiasmo, anche molto affettato. Era tintinnante di monili, anelli e catenine come la Madonna dell’Arco durante la processione di fine estate. Ha preso a far la conoscenza dei compagni con quel fare invadente, accattivante e ciarliero da talking machine che hanno un po’ tutti quelli dall’altra parte dell’oceano. Verso gli ultimi posti, come al buio di una sala cinematografica, si sono sistemati due spagnoli in viaggio di nozze, timidi e zufolanti. Parlottavano senza suoni, fitto fitto, gorgogliando a tratti, quasi due tortore al tramonto. Ultima, una signora svedese bionda, anzi bianca, rutilante di un’abbronzatura egèa color ruggine, con macchie rosa di crudeli spellature per le frustate del sole folgoratore di queste parti. Era magra e rallentata come uno di quegli euzoni coreografici e legnosi davanti al Parlamento di Atene, dai movimenti lenti di certi gasteropodi. La sua età : praticamente indecifrabile, vuoi anche per quella mia innata dote di non saperla mai riconoscere.
Il pullman ha preso a percorrere l’autostrada volgendo verso nord-est e passando all’ombra del Pentelico, sventrato da millenni per cavarne il preziosissimo marmo abbagliante. A destra e a sinistra della strada, fioriscono minuscole case di un bianco mediterraneo e luminose nel rosso della terra e delle rocce riarse, eternamente vive nella geografia greca. Non si può parlare di paesaggio verdeggiante perché, vuoi anche per effetto del moto, i colori della vegetazione e degli spazi intorno s’iridano e si fanno cangianti e brillanti, variando dal giallo all’ocra, dall’amaranto all’oro scuro. Si susseguono ulivi dalle foglie d’argento e macchie gialle di girasoli e poi melograni dai frutti color carne e sangue, ormai maturi; squamosi pini di Aleppo, verdi come rame antico; macchie rosee e purpuree di ibiscum; ciuffi di mirti dai grani neri e, ancora, bacche arancione di quell’alberello spinoso che qui chiamano pyrrocanto, ossia fiore di fuoco.
Su tutti i tetti si distinguono pannelli solari scintillanti d’acciaio e di plastica, testimoni dell’avvedutezza dei greci che noi della Magna Grecia ancora tardiamo a imitare, pur disponendo della stessa insolazione.
Ero attento a seguire il percorso e ho sgranato gli occhi quando siamo giunti alla piana di Maratona, o quello che di essa rimane da quando un lago artificiale ne occupa lo spazio antico. È questo, in ogni modo, il luogo della battaglia del quattrocentonovanta a.C. Qui gli Ateniesi di Milziade difesero la loro sudata democrazia con il coraggio delle convinzioni supreme e annientarono lo strapotente esercito persiano di Mardonio. Ho visto barbagli di scudi guizzare nel sole e palpiti d’aste, ho sentito lamenti di voci terrorizzate, scalpiccii di fuga di passi femminili, pianti di figli impauriti, lacrime nell’aria, passi quadrati di opliti in marcia, richiami di voci e grida di vittoria urlate da bocche insanguinate. Ho visto volarmi davanti agli occhi, su piedi alati, l’eroico Filippide che percorse i quarantadue chilometri che separavano il campo di battaglia da Atene, per annunciare la vittoria ai concittadini angosciati. L’ho sentito urlare con l’ultima voce: Nenikèkamen, nenikèkamen… abbiamo vinto e poi chiuderli quegli occhi pieni di polvere e di lacrime per spirare stremato.
Abbiamo costeggiato il lago che porta esso pure il nome di Maratona e che disseta Atene, per poi seguire la strada che volge decisamente verso nord-ovest. La prima sosta l’abbiamo fatta a Tebe. Vi siamo giunti verso le nove senza che Wendy avesse smesso un attimo il suo cicaleccio lezioso.
Tebe, in greco Thiva, così letto e pronunciato non riesce a evocare nulla della gloria antica. Oggi è un anonimo centro che nasconde sotto le fondamenta il tesoro della sua storia plurimillenaria. La memoria mi è corsa al mito di Cadmo che vagava alla ricerca della sorella Europa, rapita da un taurino Zeus. L’Oracolo di Delfi aveva imposto all’eroe di seguire una giovenca e fondare una città là dove essa fosse caduta al suolo. E una giovenca Cadmo seguì, scrupolosamente, fino qui, in Beozia, dove l’animale stramazzò. E qui fondò la Rocca Cadmea, Tebe. Ma la mente va pure a Sofocle e alle sventure estreme della vita che riassunse nel dramma di Edipo, creatura maledetta da un Fato perpetuamente dominatore della pochezza degli uomini e degli dèi.
A Tebe abbiamo fatto solo una sosta brevissima per bere un caffè, amaro come la delusione della polvere cui oggi la polis è ridotta. Lottavano nella mente i ricordi intatti della celebrità passata di una città , oggi non più immortale. Tebe, che prima tra le città greche batté l’irriducibile Sparta, Tebe orgogliosa piegata da Alessandro che ne dissolse il Battaglione Sacro composto di coppie di giovani amanti omosessuali, ma non pervenne a dissiparne il ricordo d’immortale grandezza. E ora? Ora qui domina il silenzio che si deposita come cenere e come la polvere dei suoi cementifici sull’orma del passato.
E in silenzio è ripreso pure il nostro viaggio: un silenzio strano e quasi ingiustificato, attesa la presenza della turbinosa Wendy. Di colpo la quiete è venuto a regnare tra noi, quasi funerea, rispettosa di una morta gloria ora richiamata solo dall’onomastica geografica.
Il pullman si è diretto verso un ponente nuvoloso. A sinistra c’è la vallata di Platea, ai piedi del Citerone, sotto strati di nuvole basse e un sole timoroso di esprimere oggi la forza della sua luce. È la Platea della battaglia! Distrutta dai Persiani di Serse nel 480 a.C., si vendicò l’anno seguente con la celebre vittoria dell’esercito greco al comando degli spartani Pausania e Aristide su quello persiano di Mardonio. Splendida vittoria e definitiva perché pose fine per sempre alle invasioni persiane. Strano destino quello di questa città ! Dopo essere stata il baluardo della Grecia, fu più volte distrutta dai vicini Tebani e più volte ricostruita, l’ultima da Alessandro Magno, sopravvivendo fino al VI sec. d.C. Poi è seguito lo spesso silenzio del tempo e l’oblio nell’anonimato che è tanto più crudele quanto più illuminato dalla gloria è stato il passato.
Abbiamo proseguito per Delfi. A destra, maestoso e imbronciato negli elmi d’argento della foschia che ne incorona costantemente la duplice vetta, ci domina il Parnaso che sovrasta Delfi mentre, poco lontana, si profila la striscia azzurra del Golfo di Corinto. Il ridente Parnaso, verdeggiante, il Parnaso delle Muse, dei fasti letterari e degli interminabili vortici mitologici è una grandezza anonima, un monte freddo e severo che incute soggezione. Ho preso delle foto… Ma a che servono le foto di un rilievo di un colore minerale? Tutti i monti sono uguali, sono fratelli, come i nasi dei bambini di cui dice Collodi. Queste foto perciò non avranno un senso evocatore che per me soltanto.
Il Parnaso delle Muse! Chiudo gli occhi e, fusi insieme, con l’armonia dei suoni, avverto il frusciare dei chitoni e il passo di danza al ritmo dei cembali…
Mi distraggo ai colori dei campi intorno, lungo l’autostrada. Sembrano un capovolto cielo stellato di giorno, punteggiato com’è dai candidi fiocchi delle distese di cotone, a perdita d’occhio. Queste distese sono talvolta interrotte da rocce che si levano dal suolo improvvise, contorte come i Là piti e i Titani del mito, rosse di un color rugginoso a macchie che sembra il sangue rappreso di un’ampia ferita. In lontananza dominano coste gialle, brulle e sassose e le balze del monte sacro alle arti che innalzandosi sembrano purificarsi delle scorie della terra nella luminosità spenta delle vette incoronate dai vapori.
Passiamo nelle vicinanze di Orcòmeno, la città del mitico Mìnia, padre di Orcòmeno stesso, capostipite degli Argonauti e luogo di culto speciale delle tre Cà riti, le Grazie care alla poesia.
Sono quasi le dieci. Costeggiamo il mitologico Cefìso, padre di Narciso, presso le cui acque Ade rapì Persèfone. Qui ancora Teseo uccise il feroce Procùste, quello dei letti a lunghezza variabile. Restano solo i nomi naturalmente, nomi inchiodati nella memoria che si rifiutano di corrispondere a luoghi così spenti, a villaggi impolverati e grigi nella loro agonia, a frammenti scomposti di un passato la cui memoria increspa invece la pelle di brividi.
Scambio qualche parola con Laurentìa. Ascolta incuriosita quello che le racconto su Alessandro, su Cheronèa, la battaglia che piegò la Grecia al dominio macedone, su Tebe. Poi, a mia volta ascolto lei e quel suo dire di cantilena in un italiano che sa di greco, melodioso e triste. Non ha le mie borie e si pone discreta ad ascoltare di nuovo il poco che so io e che lei non sa. Sull’oracolo di Trofònio di Livadìa, per esempio, una città presso la quale passa il pullman, non molto distante da Delfi. Un oracolo che non era meno importante di quello delfico, né meno intrigante. Qui, a Livadìa, dopo una liturgia purificatoria abbastanza lunga e i sacrifici animali di rito, i pellegrini bevevano alle fonti del Lete e di Mnemòsine, rispettivamente l’Oblio e la Memoria. Quello di Trofònio era un oracolo che non lasciava spazio all’incertezza del dubbio delfico. Qui, dopo i rituali e un angosciante soggiorno nel buio di una grotta, si usciva forse segnati definitivamente, se è vero che, come si legge da qualche parte, coloro che i responsi divini venivano ad ascoltarvi smarrivano il sorriso per sempre. La guida si è compiaciuta di raccontare agli altri escursionisti questa storia di Trofònio. Sulla strada che conduce da questa città a Delfi, ci ha mostrato il trivio di cui parla Sofocle e dove Edipo avrebbe fatalmente incontrato Laio, suo padre che non conosceva, e l’avrebbe ucciso. Era così che cominciava a realizzarsi l’agghiacciante presagio secondo il quale egli era condannato a uccidere il padre e a sposare Giocasta, sua madre.
Alle undici giungiamo alle rovine di Delfi: quasi a centottanta chilometri da Atene. Il villaggio che porta esso pure il nome di Delfi è a qualche distanza dalle rovine, ma non ha nulla da mostrare né emozioni da suscitare perché di evocatore ha solo un nome abusivo.
Il sito archeologico e il santuario dedicato ad Apollo sorgono in una conca naturale di singolare fascino che guarda sul golfo di Corinto. Di questo si scorge uno scorcio dall’alto del tempio. Difficile, senza una mappa dettagliata, identificare le costruzioni antiche ricavandole dalle arruffate rovine. Fin dal periodo miceneo, intorno al XIV sec. a.C., questo luogo, per la felice posizione, era considerato sacro. Si riteneva che fosse il centro stesso della terra. Qui, prima che vi sorgesse il santuario di Apollo Pizio, si adoravano Gea, la Terra, poi Demètra, la dea della vegetazione, successivamente Poseidone e, infine, Apollo. Il mito narra che qui egli aveva ucciso Pitone, il mostro dell’oracolo.
Mi inerpico lungo la Via Sacra fiancheggiata da rocce squadrate e marmi anneriti nelle cui sconnessure fioriscono rigogliosi ciuffi di capperi selvatici e di oleandri rosa. Il Parnaso domina austero con la doppia mole imbronciata di nebbie. Si passa accanto a rovine gloriose, appena ritoccate in un’approssimativa organizzazione e agli edifici che contenevano i tesori dedicati al santuario dalle città cui l’oracolo aveva predetto vittorie in guerra. Con doni munifici, infatti, si esprimeva il ringraziamento ad Apollo Pizio.
Cammino rasente la costruzione dei tesori di Argo, di Sifni, di Mègara e di Atene, che è il più importante di tutti.
Continuando lungo la salita verso il tempio, si notano i luoghi dei tesori di Cnido e di Corinto, si passa vicino alla Roccia della Sibilla e, dopo aver seguito un percorso serpeggiante, si giunge sul pianoro al cui centro sorge il basamento del tempio di Apollo. In esso, al centro, troneggiava un tripode di bronzo nel quale bruciava una fiamma perpetua posta davanti alla statua d’oro del dio. Qualche frammento di questo tripode si conserva ancora nel museo del sito. Da qualche parte, forse sotto il tripode stesso, doveva trovarsi la fossa oracolare (adyton) considerata l’ombelico del mondo (omfalos). Così era nota la cavità dalla quale si sollevavano vapori, forse allucinogeni, inalando i quali la Pizia (dal nome del pitone ucciso da Apollo), in stato di trance, prediceva gli eventi futuri.
Del santuario non resta che il basamento perimetrale, la rampa d’accesso e qualche rocco di colonna che nell’insieme poco dicono della grandiosità e della ricchezza soprattutto che doveva distinguerlo all’epoca del suo massimo splendore, intorno al IV sec. a.C. E ho una stretta al cuore nel veder crescere alta l’erba là dove fumavano gli incensi e bruciavano spezie profumate in bracieri d’argento e vasi ansati…